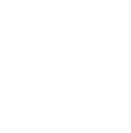L’intervento di Damiano Cantone su Sospendere la competizione di Beatrice Bonato a pordenonelegge 2015
C’è una cosa che voglio dire subito all’inizio di questo dibattito. Quello di Beatrice Bonato è un autentico testo di filosofia, come non se fanno molti. Cosa intendo con questa frase sibillina? Intendo che in questo libro, finalmente, fa quello che la filosofia dovrebbe fare: vedere qualcosa di problematico là dove nessuno vede problemi, mettere in discussione i fondamenti del senso comune, spostare il nostro sguardo per farci vedere qualcosa che se ne stava nell’ombra e agiva di conseguenza. Non si limita al commento, alla chiosa, all’ermeneutica, contiene una tesi forte, esplosiva, e la difende e la argomenta in modo coerente.
 La tesi è espressa in modo chiaro la prima riga del testo: “nella costellazione concettuale che chiamiamo neoliberismo, la nozione di competizione riveste una posizione significativa, forse fondamentale” e poi più sotto “il paradigma competitivo non è soltanto indesiderabile sul piano etico e politico, ma anche assai riduttivo nei suoi presupposti filosofici”. Dunque le sue fallacie non si verificano solo quando passo ad applicarlo, come se insomma fosse una sorta di ideale irraggiungibile ma auspicabile Il paradigma della competizione non funziona nella sua stessa formulazione teorica. E questo è il primo momento di sconcerto. Nessuno di noi è così ingenuo da pensare che la competizione sociale sia intrinsecamente “buona”, giusta e desiderabile. Ma quasi tutti pensiamo chepotrebbe esserlo. Come possiamo infatti premiare il merito, valutare le competenze, migliorare senza competere? Senza un gioco regolato da regole certe e improntato al far play all’interno del quale ciascuno viene valutato per quello che vale e ottiene quello che merita? Tutte le politiche attuali, da quelle macro, come per esempio la riforma della scuola a quelle micro che possono riguardare la nostra vita quotidiana di tutti i giorni sono guidate da questo mantra: bisogna selezionare i migliori, premiare i meriti, favorire la sana competizione.
La tesi è espressa in modo chiaro la prima riga del testo: “nella costellazione concettuale che chiamiamo neoliberismo, la nozione di competizione riveste una posizione significativa, forse fondamentale” e poi più sotto “il paradigma competitivo non è soltanto indesiderabile sul piano etico e politico, ma anche assai riduttivo nei suoi presupposti filosofici”. Dunque le sue fallacie non si verificano solo quando passo ad applicarlo, come se insomma fosse una sorta di ideale irraggiungibile ma auspicabile Il paradigma della competizione non funziona nella sua stessa formulazione teorica. E questo è il primo momento di sconcerto. Nessuno di noi è così ingenuo da pensare che la competizione sociale sia intrinsecamente “buona”, giusta e desiderabile. Ma quasi tutti pensiamo chepotrebbe esserlo. Come possiamo infatti premiare il merito, valutare le competenze, migliorare senza competere? Senza un gioco regolato da regole certe e improntato al far play all’interno del quale ciascuno viene valutato per quello che vale e ottiene quello che merita? Tutte le politiche attuali, da quelle macro, come per esempio la riforma della scuola a quelle micro che possono riguardare la nostra vita quotidiana di tutti i giorni sono guidate da questo mantra: bisogna selezionare i migliori, premiare i meriti, favorire la sana competizione.
Beatrice Bonato fa notare che questa posizione non è così granitica, che qualche sospetto o qualche voce dissidente comunque si leva, ma sottolinea anche come nessuno si sia spinto fino a teorizzare la negatività di questo paradigma, la sua pericolosità teorica oltre che pratica. In quali termini? Ne specificherò alcuni. Innanzitutto al fondo di questo paradigma rimane presupposta un’idea antropologica di natura hobbesiana, l’homo homini lupus, ovvero un essere essenzialmente individualista e posto dalla natura in competizione con i propri simili. È evidente che se la competizione è un dato naturale diventa indiscutibile, ineliminabile e l’unica cosa che rimane da fare è rendere questo dato il più regolato, onesto e meritocratico possibile. Ci sarà una buona competizione e una disonesta, ma non si potrà mai, come invece invita a fare Bonato, sospendere la competizione.
Questo ovviamente vale anche nella vita politica delle persone, laddove il massimo che ci si può augurare è che le regole funzionino e garantiscano a tutti la possibilità di mettersi in gioco con le stesse possibilità. C’è in questo chiaramente un’eco sportiva, una componente agonica ineliminabile e presupposta genetica della società, come aveva già intuito Ortega y Gasset nel suo saggio sull’Origine sportiva dello stato nel 1924. Le regole del gioco sono la cornice della democrazia, all’interno della quale ciascuno compete, si auto-migliora, mette alla prova se stesso, in un inesausto esercizio di sé, e qui il riferimento a Sloterdjik è evidente nonché esplicito nel testo di Bonato. È un esercizio funambolico, senza rete di salvataggio che possa attutire la caduta. E qui veniamo a un altro snodo molto acuto del libro, ovvero laddove si mostra come ci sia uno stretto legame, sebbene non un’identità, tra la misurazione (intesa in larga misura come auto-misurazione, auto-valutazione) e la competizione. Sappiamo come sempre più si spinga verso pratiche di autovalutazione e quelle che sono le sue attività corollarie quelle di self improvement, ovvero il miglioramento di sé continuo (il long life learning) dei quaderni bianchi europei sullo sviluppo e l’educazione. La misurazione mi mette di fronte al fatto brutale che “non siamo tutti uguali”, che ci sono delle differenze individuali che si tradurranno in disuguaglianze di performance, di resa, e che quindi verranno valutate – e selezionate – dal mercato (economico, del lavoro, degli affetti). La metafora del mercato è sicuramente la più potente e omnipervasiva oggi. Dunque possiamo dire che la comparazione è il momento preliminare della competizione, un sano bagno di realtà o di realismo che mi dice subito in che categoria potrò competere e in quale invece finirei per essere inevitabilmente sconfitto. Qui la scuola ha un ruolo molto importante: con una provocazione, mi verrebbe da dire il ruolo dell’utile idiota dell’ideologia della competizione. Per cui la sua funzione non è in primis quella, un po’ democristiana del passato, ovvero formare buoni cittadini, competenti anche dal punto di vista umano oltre che professionale, ma diventa essenzialmente valutativa, certificativa. Si valutano le competenze disciplinari, quelle trasversali, si misurano le performance secondo indicatori sempre più puntuali, con lo scopo di fornire la miglior formazione possibile per competere nella vita, nel lavoro, economicamente. Così ecco che anche le stesse scuole vengono valutate in base a rating stabiliti in base ai successi dei loro allievi, e dunque anche esse sono in competizione fra loro, e addirittura gli stessi insegnanti all’interno di un stessa scuola.
Si vede come da un punto di vista della competizione il famoso gnozi seauton, conosci te stesso, assume una declinazione quasi beffarda, che ribalta il senso socratico della comprensione autentica e fondamentalmente mai raggiunta della propria essenza, per tradursi in una serie di dati misurabili e perfettibili, tabelle, zone di sviluppo e potenziali da esprimere che – come nota acutamente Bonato – avranno anche di mira il potenziamento della performance vera e propria ma di certo non la felicità dell’individuo, né il miglioramento generale della giustizia o della dignità umana.
Cosa c’è dunque in gioco in una forma di competizione di questo tipo? Di nuovo, non solo la nostra esistenza pratica, pur importantissima, né solo le politiche e i poteri che concretamente la governano. A essere in gioco è la definizione stessa di vita, un concetto importantissimo quanto ambiguo sul quale si impernia la maggior parte delle pratiche etiche della contemporaneità. Dalla medicina, al diritto, alla scuola – oggetto di un interessatissimo capitolo del libro – c’è oggi, direi, quasi una corsa a tentare di definire che cos’è la vita, a impadronirsi di questo concetto. Non per nulla quello di biopolitica è uno dei termini, coniato da Foucault nel 1978, che negli ultimi tempi è stato più usato dai filosofi e dai politologi per indicare da una parte la gestione del corpo umano nella società dell’economia capitalista, la sua utilizzazione e il suo controllo, e dall’altra la gestione dell’uomo come specie, base di processi biologici da controllare e indirizzare. La competizione dunque, lungi dall’essere un dato naturale, è una ben precisa antropotecnica, un progetto di gestione dell’umano. E, come dice Bonato nel capitolo che si intitola “Misure e contromisure”,
«Alla base dell’incitamento alla competizione si pone un progetto di controllo e di riduzione, piuttosto che di allargamento, delle libertà tradizionalmente associate al modello della società liberale. Un progetto di monopolio, o quantomeno, di divisione del mercato – nel senso più ampio possibile del termine – tra pochi soggetti dotati di adeguata potenza economica e tecnologica per fronteggiarsi» (p. 127).
Ecco il punto conclusivo: l’idea di competizione maschera il suo esatto, osceno, opposto: ovvero una volontà di controllo, conservativa, che vuole semplicemente mantenere le strutture economiche di potere nello stato in cui sono. Porre il problema della validità etica della competizione individuale significa porre un problema di libertà e di giustizia, poiché la competizione, lungi dall’essere un fair play, è un gioco che è truccato fin dalla sua stessa concezione. Nella parte finale Bonato individua però delle possibili “sospensioni della competizione”, delle zone minime di libertà, degli spazi etici nei quali fuggire a questi elementi costrittivi. È questa la parte del testo che certamente rimane più aperta a una possibile discussione.