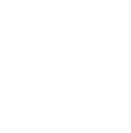Intervista di Claudia Furlanetto a Eugenio Borgna attorno al libro Parlarsi. La comunicazione perduta, Einaudi 2015.
Pordenonelegge, 19 settembre 2015.
 Parlarsi. La comunicazione perduta.
Parlarsi. La comunicazione perduta.
C.F. Cominciamo a riflettere a partire dal titolo che è una sorta di caleidoscopio semantico. Parlarsi può essere inteso come un parlare intersoggettivo, parlare all’altro, ma anche come un parlarsi intrasoggettivo, un parlare a sé. In che relazione sono queste due dimensioni del parlarsi? Anche il sottotitolo lascia intravvedere più direzioni possibili di senso: la comunicazione è perduta quando è vuota chiacchiera, ma c’è un perdersi nella comunicazione, che è fatta di silenzi, di parole insufficienti a dire ciò che si prova, dove la comunicazione si apre a nuove possibilità. Può introdurci e guidarci in queste molteplici direzioni di senso cui allude il titolo della sua opera?
E.B. Una domanda bellissima, come ogni sua domanda, che si confronta con la molteplicità dei significati che alcune parole, queste creature viventi, hanno in sé, ma che si confronta anche con il fatto che un testo scritto, lo diceva Platone nel Fedro, si consegna indifeso agli occhi di chi lo legga. Sulla scia di queste premesse, vorrei dirle che, nelle intenzioni dell’editore e mie, il titolo avrebbe dovuto rimandare alla sua dimensione intersoggettiva, alla sua dimensione relazionale, e nondimeno in parlarsi si nasconde questa altra dimensione, la dimensione intrasoggettiva, come la prima fondata sulla relazione. Ma lei, straordinaria traduttrice di Jacques Derrida, ne ha colto immediatamente la dicotomia, e come potrei non esserle grato? Come anche delle diverse connotazioni semantiche del sottotitolo che personalmente avrei indicato come titolo. Nella mia intenzione avrebbe dovuto indicare la forma di comunicazione, quella verbale, sempre più perduta, in famiglia, nel deserto di silenzi divorati dalle immagini della televisione. Ma, certo, questa comunicazione perduta può essere interpretata nel senso che lei indica con questa sua straordinaria capacità di decifrazione semantica di un testo.
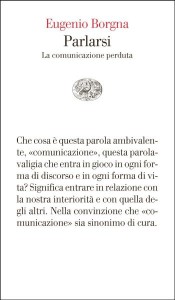 Parlarsi come esercizio della cura in psichiatria
Parlarsi come esercizio della cura in psichiatria
C.F. C’è un parlarsi intersoggettivo nella cura, legato all’ascolto delle emozioni ferite, che richiede da parte dello psichiatra una sospensione di ogni pregiudizio, inteso anche come schema mentale, concetto, teoria che possa impedire di incontrare l’altro nella sua specificità, singolarità e originalità. Il primo schema a saltare in questo tipo di approccio è quello di normale e anormale. In questa idea di cura, intesa come far posto alla singolarità di ciascun individuo e, all’interno della vita di ciascuno, far posto ad ogni tonalità emotiva, ad ogni affetto che si presenta, ha ancora senso parlare di guarigione, di ritorno al “normale”? Cos’è la guarigione in questa prospettiva?
E.B. L’articolarsi di un colloquio psicoterapeutico, almeno alla luce di una psichiatria fenomenologica, ha scansioni diverse: la prima è quella che, mettendo fra parentesi ogni conoscenza clinica, entra in contatto con una paziente, o un paziente, su di un piano di ascolto del loro modo di essere persone che stanno male: in questa scansione non si fa diagnosi; nella seconda scansione, sia pure nel rispetto assoluto della sofferenza, ci si avvia alla comprensione delle cause che hanno condotto al malessere, e dunque alla diagnosi della malattia, se questa esiste; e nella terza, e ultima scansione, si ricostituisce la relazione iniziale, intessuta di ascolto e di contatto personale, e ricondotta alla introspezione e alla immedesimazione, ma non alla identificazione (alla Einfühlung, e non alla Einsfühlung, nel senso di Max Scheler), come radicali strumenti di conoscenza. Solo parlando, e ascoltando, è possibile capire se tristezza e angoscia, inquietudine e disperazione, siano espressione di malattia, o non invece modi di essere della normalità.
Il silenzio degli adolescenti
C. F. Occorre parlarsi. Tuttavia, dicevamo, la parola non ha l’ultima parola nella comunicazione. Essa è fatta sì di parole, ma anche di silenzio e corpo vivente. È il silenzio correlato ad un ascolto puro ed empatico l’ultima frontiera della comunicazione. Allora cerchiamo di calare questa questione in esempi, nei rapporti concreti, su cui lei, dott. Borgna, si sofferma sempre con generosità nei suoi libri. Come possiamo ascoltare i silenzi degli adolescenti affinché essi non ci risultino problematici, ma – appunto – un’estrema, talvolta provocatoria, possibilità di comunicazione?
Pensando alla scuola lei rivolge, anche attraverso le parole di Raffaele Simone, un monito, affinché essa non chiuda le porte a una conoscenza che viene dal mondo della vita, che oggi per i giovani è anche un mondo di comunicazione digitale – mediasfera – la chiama Simone. La proposta di Simone è quella di consigliare alla scuola di stare al passo con i tempi, i tempi di una conoscenza sempre più informatizzata, quindi veloce, fresca che, di conseguenza richiede un rinnovamento dei contenuti. Mentre, secondo lui, la scuola applica strumenti nuovi a contenuti vecchi. Posso anche essere d’accordo per certi aspetti, ma non crede che sia proprio il sostare su temi che da solo l’allievo non avvicinerebbe, perché fuori dalla comunicazione digitalizzata, come la poesia e la letteratura antica, ad esempio, o la filosofia, che consenta all’allievo di apprendere gli strumenti per una comunicazione più personale e profonda? Il sapere trasmesso dalla mediasfera sviluppa, come dice Simone stesso, una dimensione emotiva che è quella della simpatia, ma non l’empatia, che invece può essere sviluppata attraverso saperi più riflessivi, per i quali è giusto che il tempo a scuola si sospenda, esca dal flusso mediatico incessante. Come sviluppare l’empatia in una società che spinge i giovani ad essere solo o perlopiù simpatici?
E.B. Certo, le parole non sono l’ultima frontiera della comunicazione che sopravvive talora solo nel silenzio, e nel corpo vivente; ma, se non è difficile comprendere i linguaggi del corpo vivente, dei volti, degli sguardi, delle lacrime e del sorriso, è difficile avvicinarsi alla comprensione dei molti antitetici contenuti intenzionali del silenzio, e in particolare del silenzio degli adolescenti che può conseguire al male di vivere, al dolore dell’anima, al rifiuto di persone, e di situazioni, a tensioni autistiche, a nostalgia della infanzia, a incomprensioni familiari, ai deserti luoghi che sono talora divenute le famiglie, alla sfida alla autorità, e ad altre cause ancora; e come riconoscerle? Un compito al quale sono chiamati genitori e insegnanti, e in casi estremi anche psichiatri: un compito al quale non è possibile ovviamente abdicare, e al quale ci si avvicina se si riesce a fare maturare una climax di fiducia: premessa indispensabile ma come crearla? Sfuggendo alle certezze, e rimettendosi ogni volta in gioco, ripensando ai motivi interiori delle nostre adolescenze, rivivendole, e sulla loro scia cercando di immedesimarci nei modi di fare silenzio degli adolescenti, e affidandoci alla intuizione che in alcuni di noi, al di là delle nostre culture, consente di cogliere l’indicibile della vita.
L’area sconfinata delle interpretazioni: nei due libri, e in uno in particolare, di Raffaele Simone mi è sembrato di intravedere non l’elogio della comunicazione digitalizzata, della mediasfera, ma la necessità di tenerne presenti alcuni aspetti nel contesto della comunicazione tradizionale: rendendola più viva e più vicina ai linguaggi ai modi di parlare, e forse anche di pensare degli adolescenti. Ma lei ha molte più competenze delle mie anche nella interpretazione del pensiero di Simone. Ancora più complesso mi sembra essere il problema ermeneutico dell’empatia e della simpatia: l’una non facilmente separabile dall’altra, ed etimologicamente in sim-patia c’è più relazione che non in em-patia; ma, in ogni caso, come non pensare al pensiero di Goethe sulla simpatia considerata premessa alla conoscenza, e all’immenso libro di Scheler sulla simpatia? Sì, sim-patico ed em-patico hanno possibili più chiare differenze ma gli sconfinamenti sono continui: forse.
Migranti e la comunità di destino
C. F. Tra le riflessioni più profonde che si trovano nel suo libro vi è questa: Possiamo comunicare con le persone che stanno male, e sono lacerate da emozioni ferite, quando le riconosciamo nella loro appartenenza al nostro comune destino. La comunità di destino. Un’idea molto profonda con cui arricchire il dibattito sempre molto attivo sul tema della comunità, penso alla comunità inoperosa di J.-L. Nancy, anche lui ospite quest’anno di pordenonelegge, o al libro di F. Stoppa Istituire la vita, dove si parla di comunità, presentato a pordenonelegge lo scorso anno. In questo suo libro aggiunge alle figure della sofferenza, che contribuiscono a costruire questa comunità di destino, una nuova figura, il migrante, il rifugiato. È nella misura in cui ci immedesimiamo nella sua sofferenza che è solitudine, che è nostalgia, che è paura, che è disperazione che possiamo contribuire a costruire una nuova mondiale comunità di destino. Siamo tutti migranti?
E.B. Sì, siamo tutti migranti, una splendida immagine, che universalizza immediatamente la connotazione umana della accoglienza a chi da terre lontane si allontana in vista di una salvezza possibile per sé e per i propri figli. Ma questa accoglienza costa fatica ed esige impegno, non solo pubblico, ma personale, e anche le nostre abituali parole, con cui cerchiamo di tematizzare il dovere morale della accoglienza, si sbriciolano nelle sabbie mobili delle nostre indifferenze, e anche solo delle nostre stanchezze e delle nostre preoccupazioni. Forse, solo se riconosciamo il valore non solo ideale ma pratico di quella che è possibile chiamare comunità di destino, abbiamo parole che ci impegnano sui fronti aperti di una accoglienza che ha diversi modi di manifestarsi, e che ha come suo comune denominatore il rivivere la solitudine, l’angoscia e la disperazione dei migranti, dei profughi, come se fossero la nostra solitudine, la nostra angoscia e la nostra disperazione.
Dalla clinica all’etica
C.F. L’ incessante richiamarsi alla letteratura, ai poeti, alla filosofia hanno progressivamente allontanato la sua riflessione, la sua opera dall’orizzonte della psichiatria clinica, con le domande sulle cause delle malattie, sulle cure farmacologiche, ecc. per portarla su ambiti dove la pratica terapeutica diventa esercizio di ascolto e di apertura alla sofferenza dell’altro anche come costitutiva della costruzione del proprio sé. Lei invita tutti a fare questo esercizio di apertura alla sofferenza del prossimo come costitutivo del proprio sé, a prendersi cura dell’altro avendo cura delle proprie parole e dell’ascolto delle parole dell’altro. Impossibile non richiamare alla mente autori come Emanuel Lévinas o Paul Ricoeur. Come esercizio etico l’apertura alla sofferenza psichica è possibile a tutti, invece non lo è la pratica clinica. Le chiedo se è d’accordo nel considerare la psichiatria fenomenologica, da lei sviluppata nel corso di diversi decenni, una prospettiva non solo clinica ma anche etica.
E.B. Non posso non essere d’accordo con lei nel considerare non solo la psichiatria fenomenologica, ma la psichiatria tout court, come una disciplina che, se non è fondata eticamente, tradisce la sua ragione d’essere umana, e anche clinica. Ma lei definisce splendidamente gli orizzonti di senso della psichiatria quando dice che la pratica terapeutica in psichiatria è ascolto e apertura alla sofferenza dell’altro: cosa alla quale, sia pure ovviamente in forme diverse, siamo chiamati tutti, psichiatri, o non psichiatri. Senza dubbio, nei miei lavori è avvenuto questo spostamento dalla clinica all’etica ma, in ogni caso, la clinica sta nello sfondo anche nei miei ultimi lavori.
Scuola e passione della speranza
C.F. Anche in questo suo libro lei si rivolge a chi insegna, per ricordare di non cedere all’uso di una comunicazione razionale o calcolante, ma di alimentare la comunicazione della leopardiana “passione della speranza”. Possiamo sviluppare questo suggestivo invito?
E.B. In risposta a questa domanda vorrei solo ricordare quello che sulla speranza hanno scritto Blaise Pascal (“Noi non viviamo ma speriamo di vivere”), Giacomo Leopardi (“La speranza, cioè una scintilla, una goccia di lei, non abbandona l’uomo, neppur dopo accadutagli la disgrazia la più diametralmente contraria ad essa speranza, e la più decisiva”), Walter Benjamin (“Solo a favore di chi non ha più speranza ci è data la speranza”), e Ernst Bloch (“L’importante è imparare a sperare”). Fra queste definizioni della speranza, che sono ovviamente tutte di indicibile significazione umana e fenomenologica, vorrei nondimeno sottolineare quella di Walter Benjamin, che ci richiama al dovere della speranza, alla sua radicale fondazione relazionale, alla esigenza di non lasciare morire in noi la speranza, perché solo così essa rinascerà in chi l’abbia perduta, e abbia nonostante tutto a desiderarla: come ultima zattera di salvezza. (Questo ha scritto Friedrich Hölderlin: “Dove è il pericolo, cresce / anche ciò che dà salvezza”.) Ma, non lasciare morire in noi la speranza, significa nel contesto di una cura in psichiatria tenere presenti le risorse interiori che ogni paziente ha in sé, e confidare in esse al di là dei protocolli standardizzati; e, a questo riguardo, vorrei ricordare le ricerche svolte a suo tempo da Luc Ciompi, che è stato direttore della Clinica psichiatrica della Università di Berna in Svizzera, e che hanno dimostrato (statisticamente) come la incidenza terapeutica dei farmaci cresceva nella misura in cui nei medici curanti non veniva meno la speranza che quello, che sembra impossibile, è ancora possibile. Non so se nella scuola si possa pensare alla stessa cosa. Insomma, nel solco di queste riflessioni ciascuno di noi, quale che sia l’area dei suoi compiti, dovrebbe rivivere la speranza nella sua apertura al futuro, e nella sua sorgente di intersoggettività.
Le sue domande, Claudia Furlanetto, sono state splendide, e hanno fatto riemergere dal mio testo motivi tematici frammentari e virtuali ai quali ha dato nuova vita. La mia gratitudine e la mia stima senza fine. Eugenio Borgna
Nota a margine Il testo qui presentato, composto da mie domande e dalle risposte di Eugenio Borgna, riprende e sviluppa una conversazione con il noto, stimato e amato psichiatra italiano, che si è tenuta a Pordenone in occasione dell’ultima manifestazione di pordenonelegge.it. Le domande sono state mosse dal suo ultimo libro, Parlarsi. La comunicazione perduta, edito da Einaudi. Non riprendo le parole che ho usato in occasione della presentazione a pordenonelegge. Intendo piuttosto condividere un pensiero, che nasce dalla percezione della singolare peculiarità di questo incontro con Eugenio Borgna, in cui un posto preciso hanno avuto e hanno le parole dell’elogio, dell’elogio dell’altro.
Le parole, che Eugenio Borgna mi dona nelle sue risposte alle domande, con cui evoca l’assoluta e indefinibile singolarità dell’altro, meritano non solo un ringraziamento, che ho occasione di rivolgergli pubblicamente, ma anche una riflessione che tolga tali parole di elogio dall’ambito della cortesia formale, dell’iperbole retorica, per collocarle nell’ambito ben più significativo dell’esercizio etico di riconoscimento dell’altro, che costituisce – a mio parere – il tratto caratteristico del pensiero e della sensibilità di Eugenio Borgna. Parlarsi comporta un chiamare costantemente accanto a sé l’altro, l’interlocutore attento, onorandolo e facendogli posto nel proprio vitale atto del pensare; tanto più lo si stima, tanto più le sue parole saranno capaci di portarci in profondità. Questo ho appreso dagli elogi di Eugenio Borgna, l’effetto di risonanza che le parole scelte con cura, accompagnate da una stima infinita dell’altro, producono nella nostra vita psichica. Reciprocamente.
Detto questo, rinuncio a ricondurre a più modesta dimensione i meriti che mi attribuisce Eugenio Borgna. Preciso solo che ho avuto il piacere di tradurre una sola opera di Jacques Derrida, Stati d’animo della psicanalisi. L’impossibile aldilà di una sovrana crudeltà, ETS, Pisa 2013.
Claudia Furlanetto