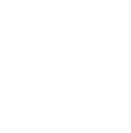Colloqui sull’individuo 4. 17 aprile 2016
Colloqui sull’individuo 4. 17 aprile 2016
CONDIVIDERE IL CONFINE
Un’eccezione così comune. Intervento di Beatrice Bonato
Jean-Luc Nancy è un filosofo di cui cogliamo in modo sempre più chiaro l’importanza e la statura. Da alcuni decenni sulla scena filosofica europea, ben conosciuto in Italia dove è spesso ospite di convegni e manifestazioni, egli è stato una presenza forte nel dibattito filosofico sul tema della comunità, in cui sono intervenuti Alain Badiou, Giorgio Agamben, Roberto Esposito, lo stesso Bruno Moroncini. Un fitto dialogo e un confronto complesso, anche polemico, si svolge nei libri di Nancy con la filosofia francese della seconda metà del Novecento, da Bataille a Lacan a Blanchot. Resta fondamentale il rapporto con Derrida, suo maestro – sebbene solo di dieci anni più vecchio – e soprattutto suo amico.
Essere singolare plurale, l’opera da cui sono tratte le pagine lette nell’incontro dello scorso 17 aprile, esce in Francia nel 1996. Senza essere uno spartiacque, è tuttavia un lavoro che si colloca, con altri, in un momento di svolta rispetto ai testi degli anni precedenti, dominati dal tema della comunità. Il saggio La comunità inoperosa (1983, poi ampliato nel 1986, Cronopio, Napoli 1992), scritto, nella seconda versione, in risposta a La comunità inconfessabile di Blanchot, era stato il punto d’arrivo di un passaggio tormentato attraverso il pensiero di Bataille, che doveva concludersi con un congedo. Rispetto a questa fase, proprio Derrida vede accentuarsi in Nancy, sul finire degli anni Ottanta, l’interesse per altri temi. In effetti, nell’ultimo quindicennio la riflessione di Nancy si è rivolta con sempre maggiore insistenza alle questioni del corpo, dell’immagine, dell’arte, nonché al Cristianesimo da cui tali motivi sono tenuti insieme. Nella monografia Le toucher, Jean-Luc Nancy (2000, Marietti, Genova-Milano 2007) – libro dal titolo intraducibile nel suo gioco tra il verbo “toccare” e il sostantivo “tatto”, sdoppiato a sua volta tra senso del tatto e discrezione – Derrida individua una svolta che culminerebbe in Corpus (1992, Cronopio, Napoli 1995), libro espressamente dedicato alla corporeità, all’“estensione” dell’anima. Come recita un’enigmatica frase di Freud, rilanciata senza sosta da Nancy, “Psiche è estesa, e non ne sa nulla” – “Psyche ist ausgedehnt, weiss nichts davon” (Corpus, p. 21). Non si deve però interpretare questa svolta, se c’è, come un passaggio netto dai temi politici a quelli estetici, dalla comunità al corpo e al tatto, quanto come il tentativo di pensare qualcosa che li accomuni: di pensare l’essere in comune dei singoli senza postulare una comunità che li raccoglierebbe o li accoglierebbe precedendoli. Il “con” della comunità sarebbe allora paragonabile al tatto, inteso come capacità di toccare senza toccare, di toccare l’intoccabile, che poi non è altro se non il confine tra il pensiero e il corpo, il confine tra un corpo e l’altro, il confine tra gli individui corporei.
Seppure presente, il tema del corpo non è al centro di Essere singolare plurale, che prende le mosse piuttosto da una questione all’incrocio tra la fenomenologia dell’intersoggettività – già affrontata nelle Meditazioni cartesiane da Husserl – e l’analitica esistenziale di Essere e Tempo, dove Heidegger pone l’attenzione sul Mitsein, l’essere-con-altri del Dasein. Nancy tocca e liquida la questione del solipsismo, evoca Descartes, con il quale si era confrontato a fondo sin dal 1979, in Ego sum, accenna quasi di passaggio a diversi altri filosofi. Comincia con passo leggero, ma si muove né più né meno che in direzione di un’ontologia; e, da lì, traccia le linee di un’antropologia, di un’etica, di una politica, che è anche, in nuce, una critica dell’economia politica. Con un metodo che per alcuni sarà sorprendente e difficile da classificare – non certo analitico, ma neppure strettamente fenomenologico, né ermeneutico e neanche decostruttivo – articola un discorso filosofico molto ambizioso, vorrei quasi dire sistematico, se non fosse una parola piuttosto compromessa. Eppure è proprio un sistema che espone procedendo, per così dire, in modo “sincopato” – introduco di passaggio un termine non casuale – attraverso lampi e interruzioni, cadute e colpi, sospensioni e brusche riprese.
Vediamo, dunque, di metterci in dialogo con questa pagina di Essere singolare plurale: “La gente è strana”. (vedi Foglio sala). Heidegger è qui convocato apertamente, perché Nancy porta alle estreme conseguenze l’approccio ontologico di Essere e tempo, scegliendo di intraprendere l’analitica esistenziale, via d’accesso all’ontologia fondamentale, a partire dalla quotidianità media, dal livello banale del nostro essere insieme.
Quante volte avremo detto “La gente è strana”, oppure “La gente è pazza”! Cosa ha questa frase così comune per attirare l’attenzione, al punto da venir considerata “un’attestazione ontologica fondamentale”? Proprio così la definisce Nancy; e forse vale la pena ricordare che “attestazione” è una parola chiave nella filosofia di Paul Ricœur, nome poco evocato nelle pagine di Nancy, il quale tuttavia aveva discusso con lui la sua tesi di dottorato su Kant. Attestazione, scrive Ricœur, è una certezza “non dossica”, che somiglia alla fiducia, al credito, alla fede (cfr. Paul Ricœur, L’attestazione, appena ripubblicato in Dall’attestazione al riconoscimento. In ricordo di Paul Ricœur, a cura di F. Scaramuzza, Mimesis, Milano-Udine 2016).
Avviciniamoci ora di più al testo di Nancy, cercando di esplicitarne i sottintesi. A un primo livello la frase ci attesta la banalità della posizione individuale di chi la pronuncia. E anche la sua bêtise – direbbe forse Derrida. Ha la stessa sfumatura di una frase come “La stupidità non è il mio forte”, che Paul Valery fa pronunciare al suo personaggio Monsieur Teste, e che Derrida commenta con grande sottigliezza nel seminario La bestia e il Sovrano. (Vol. I, 2008, Jaca Book, Milano 2009). Ciascuno di noi si auto-pone prendendo distanza da tutti gli altri, si eccettua dalla massa enunciando la propria differenza. Ѐ questo il movimento dell’Io che si pone come soggetto sovrano separato, fuori dal “comune”. Qual è dunque il senso di questo primo riconoscimento? Credo che la risposta di Nancy vada così interpretata: prendere atto del fatto che la nostra posizione individuale è inseparabile da questa banalità, e comprendere quanto questa banalità sia comune, non è cosa da poco. Anzi, vorrei aggiungere, è questo il primo importante passo di un esercizio etico. Prenderne atto vorrebbe dire cogliere insieme l’inevitabilità della nostra banale presunzione di essere unici e speciali e, nel contempo, sospenderla, disattivarla.
Ma il discorso poi si fa più complesso. Nancy continua dicendo che, in questo gesto di separazione, io riconosco agli altri la medesima stranezza che attribuisco a me. Riconosco infatti, in modo non esplicito, che anch’io sono strana/o, nello stesso modo. La stranezza ha dunque a che vedere con la separazione, con la possibilità di separarsi, di eccettuarsi come tali, di “singolarizzarsi”. Quest’attestazione rudimentale dell’io e dell’altro contemporaneamente, dell’eccezione e della banalità, del fatto che l’eccezione è la banalità stessa, vale in senso empirico ma forse pure trascendentale. Significa cioè che l’Io è il più comune, sia nel senso delle “speciali” peculiarità che io mi attribuisco come individuo specifico, sia nel senso dell’insuperabile esser-mia dell’autocoscienza trascendentale. Il che però non implica che l’io sia una pura e semplice illusione o un effetto di linguaggio. L’io non è un’immagine alienante e alienata; vi è qui un aperto rifiuto delle tesi lacaniane risalenti allo scritto inaugurale sullo stadio dello specchio. Nancy considera l’io nientemeno che “un’apertura originaria”, l’aprirsi di un mondo, il venire al mondo. Non originale, bensì originario, ogni volta unico e insieme pluralmente spartito. Non si può nascondere che in queste osservazioni vi sia qualcosa di problematico. Siamo su un piano logico o psicologico? Come dobbiamo interpretare la pretesa che questo sia un discorso attinente all’ontologia? Nondimeno, mi pare che, se teniamo presente la continuità tra una tale descrizione e l’analitica esistenziale heideggeriana – cioè se accettiamo l’idea che una descrizione di un modo di essere quotidiano apra a una dimensione ontologica, allora le ambiguità della frase non appaiono più come un pretesto per analisi poco rigorose, ma diventano esse stesse la chiave per comprendere meglio il paradosso della singolarità. Va detto a questo punto che proprio il confronto con Heidegger mostra con chiarezza dove Nancy si allontani dall’orizzonte di Essere e tempo. Il più proprio è qui il più comune, e il comune non può essere ulteriormente appropriato. Lo sporgersi dell’eccezione in cui dico “La gente è strana”, versione “umile” della solenne enunciazione “Cogito sum”, è per l’appunto il riconoscimento inconsapevole che non ci può essere appropriazione. Non si dà quindi il passaggio a un “autentico” (Eigentlich), “appropriato”, “proprio” essere in comune.
C’è almeno qualche altro spunto che vorrei ancora prendere dal testo di Nancy.
– Bisogna riconoscere che le singolarità non coincidono esattamente con gli “individui”. Lo si dice espressamente: sono piuttosto pieghe, modalizzazioni. Vengono in mente sia Spinoza che Leibniz, e viene in mente la lettura e l’uso che di questa nozione fondamentale di “modo” ha fatto Giorgio Agamben in L’uso dei corpi. (Neri Pozza, Vicenza 2014, “Per un’ontologia modale”, pp. 192-227). Potremmo seguire anche altri fili. Per esempio, nel primo incontro del nostro percorso Colloqui sull’individuo, commentando Il principio di individuazione di Duns Scoto, Damiano Cantone si era soffermato sulla nozione di pre-individuale introdotta da Simondon, suggerendo di seguirne gli sviluppi nel contesto scientifico, per cogliervi una di quelle nuove categorie filosofiche delle quali il pensiero filosofico contemporaneo avrebbe bisogno per riuscire a parlare, con un linguaggio finalmente adeguato, di una realtà mutata. Non so però fino a che punto si possa accostare il concetto di pre-individuale di Simondon a quello di singolarità di Nancy; certamente vi è un’aria di famiglia, ma nel secondo caso la singolarità non è una modalità che preceda l’individuazione di un individuo, semmai una piega ulteriore, un movimento di caratterizzazione attraverso una divisione. La singolarità certo non è intesa come un tutto metafisico, nel senso della totalità personale; è il modo in cui si esprime, in modo ogni volta unico, il comune distinguersi come un io.
– L’io viene al mondo bruscamente, come il primo battito di un cuore, come un primo vagito. Ho evocato poco fa la sincope. Perché questa strana parola? Essa riveste ben tre significati. C’è un significato musicale, e lo ha spiegato brevemente ma in modo efficace il jazzista Pier Paolo Gregorig. Il jazz, mi ha detto anche in una battuta Renato Miani “è tutto sincope”. Cioè, per restare all’effetto, è interruzione dell’aspettativa psicologica, rottura della continuità estetica, sorpresa. In medicina la parola sincope indica il temporaneo e improvviso venir meno della coscienza, accompagnato dalla caduta, dalla perdita brusca, violenta, della posizione eretta. In linguistica, infine, è ancora a una caduta, quella di alcuni fonemi, per esempio nell’evoluzione dal latino alle lingue neolatine. Per Nancy la sincope annuncia lo svanire del limite, l’esperienza del sublime. (Un pensiero finito, 1990, Marcos y Marcos, Milano 1992, p. 100). Eppure l’immagine della sincope – non direttamente nominata ma certo evocata anche in Essere singolare plurale nei termini “colpo, shock” ecc. – si impone a proposito di qualcosa che sembrerebbe il suo contrario; si collega cioè all’emergere dell’io cosciente individuale, alla sua trasparenza, al darsi dell’identità io-io, Ego sum. Com’è possibile? L’associazione colpisce – è il caso di dirlo –, ma non sembra del tutto chiara. A meno che non si rompa l’identificazione tra io e coscienza, e non si consideri l’io come una breccia nella coscienza, un taglio nel suo continuum, una sorta di “risveglio”.
– Il colpo dell’ego sum si produce come un colpo di dadi, un lancio o un’esplosione: sparpaglia, dissemina, pluralizza. Divide e crea le condizioni del con-dividere (partager). Ma cosa si condivide? Nient’altro che ciò che ci divide: l’io, la separazione, il rétrait dell’altro, il confine costituito dalla pelle. E la morte, nel senso che non ne esiste un’appropriazione individuale e tantomeno comunitaria.
Torniamo ora alla singolarità come piega, tratto, indice della particolarità di qualcuno. Ciò che ci permette di riconoscerlo, come in una foto, per quell’andatura, quel gesto, quel modo di piegare la testa ecc. Si tratta di quei dettagli in cui si condensano le vite individuali, che non potrebbero essere raccontati senza diventare patetici – rinvio ancora alle suggestive osservazioni di Agamben a proposito degli annunci sui giornali dove tante persone cercano, fallendo sempre, di presentarsi nella loro particolarità attraverso descrizioni disarmanti (cfr. L’uso dei corpi, cit., pp. 293 e sgg.). Prestare attenzione a tali tratti è la “competenza dell’amore”, potrebbe dire Luc Boltanski. L’amore si rivolge infatti alla singolarità, non all’individuo autosufficiente soggetto dei diritti liberali, e neppure alla persona come unità spirituale. Nancy continuerà d’altronde a respingere la fusione tra i singoli, per insistere sempre sul fatto che in ogni caso essi si toccheranno sul “confine”, al limite, senza compenetrarsi mai.
Vorrei a questo punto tentare un salto forse un po’ ardito, per raggiungere, da Essere singolare plurale, alcuni esiti più recenti. In questi ultimi vent’anni, dal 1996 a oggi, Nancy ha scritto molto, muovendosi in diverse direzioni. Derrida ne presentiva il disegno e lo identificava in un pensiero, che è anche una critica, del contatto e del tatto. Al tempo stesso era colpito dal proposito di intraprendere un progetto pazzesco, la “decostruzione del Cristianesimo”. Nelle pagine di Le toucher Derrida si mostra attentissimo alle movenze di pensiero dell’amico; vorrebbe toccarlo, scrive, con il massimo tatto – e, nello stesso tempo, le toucher, toccare lui, Jean-Luc Nancy, entrare davvero in contatto con lui; vede molto bene che Nancy è lontano dall’impiegare senza cautele il concetto di “carne”, tanto caro invece a Merleau-Ponty. Semmai, il dubbio di Derrida riguarda la spericolata pretesa di poter decostruire – compito immane e forse troppo ambizioso per essere veramente ispirato alla decostruzione – qualcosa come il Cristianesimo. (Ma in fondo, perché no?)
In effetti, dopo la morte di Derrida Nancy ha pubblicato due volumi sulla decostruzione del Cristianesimo, La dischiusura e L’adorazione (2005 e 2010, Cronopio, Napoli 2007 e 2012).
Ora, per procedere con un po’ di ordine, come si legano la critica del contatto e la filosofia del tatto con la decostruzione del Cristianesimo? Solo qualche indicazione: pensiamo al tocco divino, alla grazia che salva. Al miracolo della guarigione del corpo malato che si prolunga nell’intervento spirituale, su cui è fondata la fede. Certo, è anche vero che la fede deve prescindere dal toccare diretto – noli me tangere – ma forse solo perché si affida a un contatto più intimo. Il contatto culmina nell’eucarestia. Hoc est enim corpus meum. In questa formula si condensa il nocciolo comunitario del Cristianesimo. Il corpo divino è offerto in sacrificio. Chi ne mangerà sarà salvo, vivrà. Non c’è bisogno di dire quanta sia la potenza di quello che non si presenta solo come un simbolo, ma come un sacramento. Dunque, come affrontare una tale potenza, una tradizione così pesante? Non si tratta di secolarizzazione (L’adorazione, pp. 68-69); si tratta di proseguire, in rapporto al Cristianesimo, la critica del pensiero della comunità che aveva in precedenza il suo epicentro nel confronto con il pensiero di Bataille. Il lessico della comunità, così come si è imposto nel Novecento, è infatti in un certo modo un lessico secolarizzato, ma non decostruito e non dischiuso. La dischiusura (Déclosion) è una mossa più radicale. Anzi, più che una mossa consapevolmente attuata, è qualcosa che sta avvenendo, che è già avvenuto. Il Cristianesimo si è svuotato, dio è morto. Cosa resta? Restano, secondo Nancy, le sue aperture. Le sue “virtù”: fede, speranza, carità (L’adorazione, cit., cap. III, “Misteri e virtù”). Nancy è ben consapevole che la decostruzione del Cristianesimo non lascia indenne l’umanismo. Ma cosa significa in rapporto alla questione della singolarità e dei singoli che noi siamo? Alla fine troviamo l’adorazione, atteggiamento che accetta la dipendenza, addirittura passione della dipendenza. Che differenza c’è, dunque, da quelle dipendenze di cui siamo tutti preda nella società neoliberale? La differenza, risponde il filosofo, è che questa sarebbe una dipendenza da qualcosa che non è presente, qualcosa che non si può afferrare. Da qualcosa, o da qualcuno, che ci tocca restando intangibile. (Ivi, pp. 13-14).
Bisognerebbe ora, per concludere, cercare di spiegare in che modo questa singolarità intoccabile sia senza misura, incommensurabile. E in che senso le singolarità, tutte prese nella loro spartizione, vadano però anche considerate uguali. Nel loro essere “senza prezzo” è il loro prezzo in quanto pregio, la loro dignità, come la chiamava Kant. Alla pagina sulla misura che è stata letta da Essere singolare plurale, aggiungerei qualche riga scritta un quindicina d’anni dopo:
“Ѐ a questo prezzo, a questo valore inestimabile che si rivolge l’adorazione: esso è la valutazione dell’invalutabile. Ebbene, noi vi siamo portati, vi siamo spinti. Ecco perché nella virtù bisogna comprendere l’energia della pulsione”. (Ivi, p. 93). Dove colpiscono, insieme, l’indicazione dell’eccentricità del Cristianesimo (dischiuso e decostruito, beninteso, impresa forse non semplice) rispetto al capitalismo, e l’uso della parola “pulsione”, che Nancy impiega nel senso freudiano di Trieb. Spinta, slancio, forza: nel solco aperto da Nietzsche, in qualche modo, eppure anche, ormai, decisamente lontano da lui (ivi, pp. 98-99).