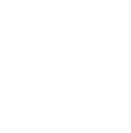Colloqui sull’individuo 1. 24 gennaio 2016
Colloqui sull’individuo 1. 24 gennaio 2016
ESSERE PROPRIO QUESTO Il Principium individuationis
Intervento di Damiano Cantone
Perché la filosofia contemporanea mostra interesse per Duns Scoto? Principalmente per la sua concezione del principium individuationis. Oggi vi mostrerò due esperienze di pensiero affini ma non sovrapponibili che vi hanno fatto riferimento, ovvero Gilbert Simondon e Gilles Deleuze. Prima però voglio fissare alcuni punti in relazione a Scoto che terremo come sfondo della nostra discussione, altrimenti rischiamo di smarrirci.
- L’essere in quanto essere è il soggetto della metafisica.
- La differenza tra essenza ed esistenza non può essere reale (non sono cioè due cose diverse). L’esistenza è solo un modo di essere dell’essenza (che può essere universale nella mia mente o singolare nell’ente, indifferentemente).
- L’essenza dunque non è singolare ma diventa tale grazie al principium individuationis che è collocato a livello della sostanza.
- Questo principio rende individuale l’esistenza dell’essenza, dunque un haecceitas (essere questa cosa qui), la contrazione dell’essenza in un ente in quello specifico modo e rapporto.
- Da un punto di vista gnoseologico, infine, la natura specifica e la differenza individuale, che sono la stessa cosa da un punto di vista ontologico, possono venir formalmente distinte.
Cominciamo quindi con il pensiero di Gilbert Simondon, che parte proprio dall’haecceitas, fin dall’introduzione alla sua opera principale, L’individuazione alla luce delle nozioni di forma e informazione. A dire la verità Simondon è una delle fonti da cui attingerà maggiormente Deleuze, sebbene sia una autore che definire poco letto è eufemistico. Vi basti sapere che la sua opera principale che abbiamo appena nominato (e praticamente l’unica, se si eccettua l’unico altro lavoro pubblicato in vita Du mode d’existence des objets techniques), viene pubblicata parzialmente nell’anno della sua morte, 1989, e l’edizione completa solo nel 2004. Si tratta di una vera e propria summa del suo pensiero, disponibile anche in traduzione italiana a partire dal 2011. Prima ne era uscita una parte, circa un terzo del totale, corrispondente all’edizione francese del 1989.
Ho speso un minuto a mostrarvi questo strano itinerario editoriale solo per farvi capire che probabilmente questo è un testo con il quale la filosofia dovrà misurarsi anche in futuro dato che a tutt’oggi sono pochi gli studi che si sono criticamente occupati di esso. Ma perché dovremmo occuparcene noi? Perché è il tentativo più radicale, dopo Scoto, di fondare il primato del principio di individuazione sia su un piano ontologico, sia gnoseologico sia metafisico. Tra l’altro è lo stesso Simondon a riconoscere in Scoto proprio un ruolo di rottura con la trattazione del principium individuationis della tradizione precedente, ovvero quella linea che va da Aristotele a Tommaso d’Aquino e che lui esamina in una corposa e interessante digressione intitolata Storia dell’individuo.
È chiaro che in Simondon individuo e individuazione non sono certo la stessa cosa, e nemmeno è possibile ridurre l’uno all’altra. La tesi del libro è la seguente: classicamente l’ontologia ha già sempre considerato l’essere come individuato, l’individuo è sempre stato un “fatto”, un dato di partenza per poter stabilire quali processi logici e quali principi metafisici siano intervenuti nella sua definizione. Nelle due grandi ipotesi sull’individuo, quella atomista (per cui ogni ente è un aggregato transeunte di atomi individuali) o quella ilomorfica (per cui invece l’individuo è dato da una precisa configurazione di materia e forma) si presuppone sempre una sequenza temporale definita: c’è un principio di individuazione, che si esplica in un’operazione o un processo di individuazione e alla fine si arriva a un individuo finito, un ente concreto. Questo schema ha il difetto di dare per presupposti e lascia impensati proprio gli individui, cioè i risultati del processo, e non giunge quindi a mostrare una vera e propria ontogenesi, ma solo una giustificazione a posteriori dell’esistenza degli enti individuali. Detto in altri termini, l’individuo esiste necessariamente, è il telos necessario di un processo
La proposta di Simondon è dunque quella di “conoscere l’individuo attraverso l’individuazione anziché l’individuazione a partire dall’individuo”, il che significa occuparsi di come è possibile che l’individuo emerga a partire da un ambiente, da un momento ontologico dell’essere pre-individuale, nel quale ancora non si danno gli individui. Simondon lo definisce un “essere senza fasi”, un tutto indifferenziato ricco di infiniti potenziali di sfasatura: non dovremmo concepirlo con la perfezione della sfera, ma col ribollire del magma prima dell’eruzione o con il brodo primordiale dal quale sarebbe nata la vita. Un tale essere non conosce né identità né unità e dunque non può essere pensato attraverso il principio del terzo escluso. Attenzione a questo punto: non è che principio di identità, non contraddizione e terzo escluso non si applichino all’essere, ma semplicemente non si applicano all’individuazione, ovvero all’ontogenesi, al divenire dell’essere in quanto essere. Si applicano al suo come, ma non al suo perché.
Il che porta in campo un primo ordine di problemi: i concetti della filosofia sono adeguati solo a una realtà individuata, in cui gli enti siano individuati: sono dunque del tutto inadeguati a pensare il preindividuale. Simondon si rivolge allora alla scienza, in particolare alla fisica e alla biologia, e ne mutua alcuni concetti. Il primo, che ho appena nominato, è quello di ontogenesi – un termine che in biologia indica lo sviluppo dell’individuo dalla fecondazione fino allo stadio adulto – l’altro, che vediamo ora, è quello di “metastabilità”. Metastabilità è una parola della fisica, e indica la capacità di un insieme di conservare determinate caratteristiche fino ad un certo gradiente – di intensità e saturazione – un quantum che lo fa precipitare in uno stato differente. Un esempio emblematico di questo è il processo di cristallizzazione: un sistema metastabile è un sistema ricco di energia e forza potenziali: c’è un certo grado di indeterminatezza rispetto a ciò che può derivare da questo stato della materia. Allora la più piccola particella chimica estranea al composto saturo può innescare e orientare la cristallizzazione, o come dice Simondon “Prima che appaia il primo cristallo vi è uno stato di tensione che mette un notevole energia a disposizione del più lieve accidente locale”. È evidente quanto il concetto di metastabilità sia lontano da quello di stabilità della filosofia, mutuato dal modello dell’episteme, qualcosa che sta, che è in quiete.
Ma evidentemente c’è una differenza sostanziale tra la genesi di un cristallo e la genesi di un essere vivente: infatti il vivente non è mai compiuto, serba in sé una permanente attività di individuazione. Non è il risultato dell’individuazione ma il “teatro dell’individuazione”. L’individuo vivente è al contempo un insieme che individua e si individua, è com’è e diventa com’è. E anzi, Simondon si spinge a ipotizzare che nell’individuo vivente coesista una certa quantità di carica preindividuale, una serie di potenziali che racchiude in sé. Un po’ come il virtuale di Bergson, il preindividuale non cessa di individualizzarsi, ma senza mai esaurirsi nell’individuato.
A questo proposito Simondon utilizza un altro termine preso dalla scienza, ovvero la trasduzione. Significa che l’individuo non è concepibile come elemento separato dall’ambiente in cui è immerso, e nemmeno in relazione con esso, ma solo come rapporto metastabile reale tra il tutto e le sue parti. L’individuo vivente è dunque un elemento trasduttivo, capace di mantenere una metastabilità tra sé e l’ambiente che lo circonda, di cui è parte ma dal quale si distingue. L’individuo vivente – e non faccio distinzioni di quale tipo di tratti – tende a mantenere la propria metastabilità, il che significa: una serie di processi che danno origine a una certa configurazione spazio temporale che tende a fare in modo che gli scambi con l’ambiente non determinino un crollo del sistema stesso. È un’unità pluralizzata o una pluralità unificata.
In tal senso l’elemento chiave nella trasduzione è l’informazione, che circola tra l’insieme individuato e l’ambiente. In un sistema metastabile tutte le parti del sistema scambiano in ogni momento segnali con tutte le parti: affinché si passi da segnali a significati è necessaria la presenza di un sistema individuato, ovvero un sistema per il quale un certo segnale diventa un’informazione: come dice Simondon: l’individuo è ciò mediante cui e in cui appaiono dei significati. Solo all’interno di questo sistema segnale-significato appare un tipo del tutto particolare di individuazione, ovvero l’individualizzazione, o “individuazione psichica”.
È chiaro che un funzionamento psichico deve avere per base un ente già individuato. Anche le strutture di tipo psichico (quelle che chiamiamo coscienza, desiderio, percezione, ecc.) sono a loro volta dei sistemi metastabili suscettibili in ogni momento di passare ad una fase differente. Infatti, nota Simondon, nessuno stato psichico è assoluto, ma è sempre una forma di relazione o comparazione intensiva. È ovvio che da questa prospettiva anche una distinzione mente corpo vacilla enormemente, dato che si tratta di una semplice sostanzializzazione di alcuni processi dopo che sono stati arbitrariamente separati e riuniti concettualmente.
Piuttosto, per quanto riguarda il soggetto umano – ma anche il soggetto senziente in generale – possiamo parlare per l’appunto di un “teatro di individuazioni”, una sorta di palcoscenico sul quale vanno in scena tutte le individuazioni che fanno sì che noi siamo quello che siamo, sia da un punto di vista psichico sia, e qui è anche una parte molto interessante di Simondon, collettivo. Collettivo è il nome che Simondon dà a tutti i costrutti che, pur essendo di origine umana, ci pre-esistono, dunque sono anche essi preindividuali sebbene in modo secondo rispetto al preindividuale vero e proprio. Essi sono per esempio le lingue, le strutture sociali, le culture, le religioni. È chiaro dunque come ogni soggetto per Simondon è una molteplicità singolare, ovvero una precisa e transeunte configurazione di forze che non è universalizzabile in alcun modo, dato che non c’è nulla in esso dell’ordine dell’identico e dell’analogo. E in questo di nuovo si torna a Scoto e alla sua affermazione, la prima dei nostri punti, per cui “l’essere è univoco” e si dice nello stesso modo di tutte le sue manifestazioni: sì dà un’unica ontologia, sebbene ad essa possano appoggiarsi numeroso scienze e discipline.
Dalla stessa affermazione di Scoto parte Gilles Deleuze nel 1968 – i testi di Simondon sono scritti intorno al 1964 – per sviluppare il suo discorso in relazione alla singolarità e all’individuazione. Anzi, per Deleuze c’è sempre stata una sola proposizione ontologica radicale: l’”essere è univoco”. Come mai tanta radicalità? Perché secondo Deleuze solo partendo dal presupposto della univocità dell’essere possiamo evitare di compiere un’indebita gerarchizzazione logica a priori degli enti. Gerarchizzazione che caratterizza e inficia ogni ontologia fondata sul principio di analogia. Ciò significa che in una proposizione ontologica vera e propria non è solamente il designato che è ontologicamente lo stesso per i sensi qualitativamente distinti in cui lo si esprime, ma è anche il senso stesso a essere lo stesso per tutti i modi in cui si dice l’essere. In altre parole secondo Deleuze “l’essenziale dell’univocità dell’essere non è che l’essere si dica in un solo e stesso senso, ma che si dica in un solo e stesso senso di tutte le sue differenze individuanti o modalità intrinseche”.
Da questo punto di vista Scoto, secondo Deleuze, è il primo filosofo a pensare l’essere come neutro, indifferente al finito e all’infinito, al singolare e all’universale, al creato e al creatore. Ecco allora che il tentativo di Scoto è quello di mostrare come questo essere indifferente entra in una relazione non analogica ma singolare – individuante – con gli enti. Il principium individuationis funziona in modo per così dire trascendentale rispetto agli individui concreti, contemporaneo al processo di individuazione e in grado di operare delle trasformazioni nell’individuo, dunque di dissolverlo e determinarlo incessantemente. Si può dunque tracciare una linea che accomuna Scoto, Spinoza e Nietzsche in quando pensatori dell’univocità dell’essere.
E infatti è nel testo Spinoza e il problema dell’espressione che Deleuze propone un confronto serrato tra i due modi di trattare il principium individuationis. Anche qui il punto di partenza è costituito dal fatto che l’ente si dice con lo stesso significato di tutto ciò che è, finito o infinito che sia, anche se non nella stessa modalità. Come afferma Scoto “L’infinità non toglie per nulla la ragione formale di quello cui si aggiunge” (D8 Questio 4). Per salvare la semplicità di Dio in quanto non può essere composto di parti, Scoto introduce l’idea di una distinzione formale tra quidditas distinte all’interno di uno stesso soggetto. L’intelletto, cioè afferra oggettivamente forme attualmente distinte, ma che come tali compongono un solo e unico soggetto. La distinzione formale è certamente una distinzione reale, dal momento che esprime i diversi stati di un ente, per esempio animale e razionale, ma nella misura in cui le due quiddità distinte si coordinano e compongono in unico ente. È come se avessimo a che fare, per Deleuze, con due ordini, l’ordine della ragione formale e l’ordine dell’essere, laddove l’articolata complessità del primo si concilia perfettamente con la semplicità dell’altro.
Ed ecco l’interesse di Deleuze per l’ecceità scotiana. La prima volta che utilizza questo termine lo fa in chiave anitipsicanalitica in un testo del 1977, Dialogues, tradotto in italiano con Conversazioni. Egli dà nome di ecceità a qualsiasi individuazione che non si realizza attraverso le modalità di un soggetto o di una cosa. È un piano di variazione che accade in un certo modo anziché in un altro. Può sembrare molto astratto, ma invece Deleuze porta degli esempi molto concreti, come per esempio un passeggiata, o le cinque della sera. Sono perfettamente singolari ma per nulla individuali. Si compongono di una molteplicità di elementi che non sono in nessun modo unificabili, eppure sono quelli e non altri. Vi leggo cosa ne dice lui stesso “Non ci sono più forme, ma dei rapporti cinematici tra elementi non formati, non ci sono più soggetti ma individuazioni dinamiche senza soggetto, che costituiscono dei concatenamenti collettivi”. Un’ecceità accade, non è.
È chiaro che oramai ci siamo allontanati un bel po’ da Scoto, ma stiamo cominciando a vedere come funziona il principio di individuazione in Deleuze. In Mille piani, del 1980, scritto assieme a Felix Guattari egli intitola significativamente un capitolo del testo Ricordi di un’ecceità per mostrare come una singolarità – un corpo – sia un insieme di determinati elementi materiali che gli appartengono secondo determinati rapporti. Qui non ci sono più assolutamente forme o sviluppi di forme né soggetti e formazioni di soggetti. Ci sono soltanto rapporti di movimento e di riposo, di velocità e di lentezza tra elementi non formati o almeno relativamente non formati, molecole e particelle di ogni sorta. O per usare le parole di Deleuze “ci sono soltanto ecceità, affetti, individuazioni senza soggetto, che costituiscono concatenamenti collettivi. Non si sviluppa nulla, ma avvengono cose in ritardo o in anticipo e formano questo o quel concatenamento secondo le loro composizioni di velocità. Nulla si soggettivizza, ma si formano ecceità secondo le composizioni di potenze o di affetti non soggettivati”.
Deleuze propone di considerare la singolarità secondo una logica evenemenziale: ovvero le individualità si determinano come delle emergenze, una certa configurazione della molteplicità (in Differenza e ripetizione usa la fortunata ma fuorviante espressione “anarchia incoronata”) che appare organizzata, una differenza che emerge dall’indifferenziato. Ecco allora che la differenza tra lo stato preindividuale e quello individuato è una differenza intensiva, di rapporti differenziali tra forze, e non ontologica, ovvero non è necessario introdurre nel piano di immanenza alcun elemento in più per determinare la nascita delle configurazioni singolari. Singolarità e individuo sono dunque distinti. Le singolarità emergono dal tutto attraverso un processo di individuazione, determinando perciò una certa configurazione del tutto. Ovvero, il tutto è giudicabile e dunque conoscibile solo a partire dall’emergere di singolarità, di punti a partire dai quali è possibile stabilire un sistema di riferimento. Fatto questo, ecco che nel tutto si determinano degli individui, che dunque non coincidono né si sovrappongono alle singolarità. Ad esempio il termine “elettore”, ha senso e descrive qualcosa di esistente sono all’interno di un sistema di riferimento che è quello del diritto democratico, il quale però a sua volta è problematico, nel senso che non è giustificato se non sulla base di un ontogenesi.
Probabilmente il tentativo più radicale di mostrare un’ontogenesi Deleuze lo tenta nei due testi sul cinema del 1983 e del 1985, L’immagine tempo e l’immagine movimento, testi che però oggi non possiamo affrontare adeguatamente, data la loro complessa articolazione. Vorrei invece fare riferimento a un piccolo testo del 1989, quindi risalente agli ultimi anni della produzione deleuziana, quelli in cui più forte si fa sentire il problema dell’immanenza e della singolarità. Si intitola “Risposta a una domanda sul soggetto”. In esso Deleuze osserva un concetto filosofico particolare, quello di Soggetto appunto, nella sua dimensione di dispositivo, ovvero nella sua capacità da una parte di raccogliere e descrivere alcuni funzionamenti della realtà, e dall’altra di determinare a sua volta altri funzionamenti. Tra l’altro anche quello di “dispositivo” è un termine molto interessante e non distante dai discorsi che stiamo facendo. Dispositio infatti il termine latino che i padri della chiesa di lingua latina usano per tradurre il termine greco oikonomia, (termine chiave della patristica di lingua greca che per esempio Tertulliano utilizza per descrivere il modo in cui Dio dispone gli enti all’interno del tutto. Comunque. Il concetto di soggetto in filosofia nasce – e sappiamo bene che non è sempre esistito – per assolvere due funzioni: una di universalizzazione e una di individuazione, nella misura in cui l’individuo non può più essere una cosa o un’anima ma una persona vivente. Ecco l’osservazione di Deleuze: c’è stato un progressivo movimento, uno spostamento della nozione di soggetto, in corrispondenza delle trasformazioni dei loro correlati. Nella nozione di Soggetto possiamo osservare lo smottamento di un concetto, ovvero il modo in cui i concetti si muovono, si trasformano in qualcosa di altro. Questo non perché ci siano dei progressi in filosofia, come invece avviene per esempio all’interno della scienza, come se con l’aumentare delle scoperte una determinata nozione diventi più precisa e efficace. La nozione di soggetto in Kant non è in nulla inferiore, per esempio, a quella di Husserl o Freud, semplicemente fa cose diverse. E questo perché la filosofia è un processo, ed è un processo di creazione. Un concetto come quello di soggetto non è nulla di astratto, ma è il modo in cui la filosofia si esprime nel proprio divenire. Non c’è alcun “superamento” in filosofia, non più di quanto ci sia, per esempio, nell’arte.
L’idea di progresso è a sua volta un’idea che ha una genesi storica (l’illuminismo) e corrisponde a un modo di espressione della filosofia, della scienza e della politica. I concetti dunque non sono né astratti né arbitrari: sono gli attrezzi di lavoro della filosofia. Servono in determinati contesti e per determinate funzioni. Questo implica che scomparsi quei contesti e quelle finzioni, anche il concetto deve trasformarsi, altrimenti non ha più senso.
Cosa diventa dunque la nozione di soggetto? Secondo Deleuze, nella contemporaneità si sono imposti dei tipi di individuazione che non sono più personali. Egli, riprendendo proprio il termine di Scoto haecceitas, per indicare queste forme di individuazione che non costituiscono né persone né io. La nozione di io, la nozione di soggetto, è collassata sotto la spinta di forze cui non riesce a rispondere, di funzioni che risultano inassegnabili. Anche i concetti, per riprendere il termine di Simondon, hanno un carattere intensivo e metastabile: emergono all’interno di un contesto per rispondere a un determinato funzionamento di esso, e resistono con una certa elasticità a tutti i tentativi di trasformazione del contesto. Fino a che arrivano a un punto di rottura, ed ecco che le forze che prima costituivano quella determinata configurazione che si chiamava soggetto hanno dato origine a qualcosa d’altro, di complesso e non comprensibile attraverso i dispositivi-concetti usati fino a quel momento. Si tratta di un evento, della determinazione di una configurazione di senso singolare non-individuata, che pone alla filosofia tutta una serie di problematiche di composizione, di scomposizione, di velocità e lentezza. Provocatoriamente, alla fine di questo breve testo, Deleuze afferma che bisognerebbe pensare la quarta persona del singolare, come a dire, qualcosa di assolutamente impossibile da categorizzare con la nostra grammatica concettuale ed aggiunge, cito “un x in cui riconosciamo noi stessi e la nostra comunità meglio che nei vani scambi tra un tu e un io”. La nozione di soggetto ha perso molto del suo interesse, a vantaggio invece di quelle che Deleuze chiama singolarità preindividuali e individuazioni non personali. Ma non si tratta di inventare concetti a caso, ma di confrontare campi di problemi, in modo interdisciplinare (Che cos’è la filosofia, per esempio, confronta i tre elementi di produzione del pensiero umano, l’arte, la scienza e la filosofia), vedere sotto la spinta di quali forze i problemi si trasformano ed esigono essi stessi la costituzione di nuovi concetti.
In conclusione, e come apertura per una discussione futura, possiamo dire che la rivalutazione del principio di individuazione in chiave scotiana in corso nella filosofia contemporanea passa attraverso una radicale contrapposizione all’idea di soggetto di tipo cartesiano. Questo lavoro è ancora in atto, sto pensando ad autori, per esempio, come Quentin Meillassoux e alla sua radicale messa in discussione dell’identità tra pensiero ed essere che è alla base di ogni teoria del soggetto. Seguendo questa strada si approda a una radicale messa in discussione degli operatori filosofici tradizionali, con tutte le conseguenze etiche, politiche e teoretiche del caso. Il che certo spaventa, ma a mio parere è necessario e foriero di grandi possibilità (oltre che di altrettanti rischi).
Ci sono numerosi esempi di questo processo che va dall’indifferenziato al molteplice singolare e poi all’individuato negli scritti di Deleuze, ma il tentativo più radicale di mostrare un’ontogenesi lo ritroviamo nei due testi del 1983 e del 1985 che si intitolano L’immagine movimento e l’immagine tempo. Generalmente sono classificati come due testi sul cinema e per questo motivo molto fraintesi e pochissimo letti. Eppure dentro c’è uno dei tentativi più ambiziosi di fondare un ontogenesi delle immagini, sulla scorta dell’ipotesi bergsoniana.
Effettivamente, i due testi si presentano come un commento alle tesi sul movimento esposte da Bergson in Materia e memoria e nell’ Evoluzione creatrice, in un’ottica anti-fenomenologica e anti-psicologica. Tuttavia, se è vero che il progetto deleuziano poggia sulle intuizioni bergsoniane, non va sottovalutata l’importanza dell’apporto di altre filosofie – la semiotica di Pierce e la teoria nietzschiana dell’arte, tanto per fare degli esempi – per lo sviluppo dell’opera.
Il confronto fra cinema e filosofia deve allora avvenire su un altro piano, che Deleuze chiama problematico. Il problema che la filosofia e il cinema hanno in comune – e che dunque rende possibile il loro confronto – è quello elencato da Deleuze nell’introduzione a L’immagine-movimento: il movimento della materia e la sua rappresentazione. Si parte da una crisi della spiegazione psicologica del movimento: alla fine del diciannovesimo secolo (il periodo in cui nasce il cinema), non era più possibile opporre il movimento come realtà fisica estesa nello spazio del mondo esterno all’immagine come realtà psichica all’interno della coscienza. È in questo contesto storico che Bergson scrive Materia e Memoria: in questo testo avanza un’ipotesi del tutto rivoluzionaria che colpisce molto Deleuze. Fin dall’inizio del suo libro Bergson pone un’equazione tanto semplice quanto radicale e sorprendente: “la materia è un insieme di immagini”. Egli fonda questa osservazione sul senso comune, per il quale – secondo la sua definizione – ogni oggetto esiste in se stesso e come lo percepiamo: è un’immagine, ma un’immagine che esiste in sé. Bergson voleva – esplicitamente – evitare di ricadere nelle impasse che avevano reso inaccettabili per lui le posizioni dell’idealismo, nella fattispecie quello di Berkeley, per il quale gli oggetti esisterebbero soltanto nella coscienza di chi li percepisce, e di un realismo radicale per cui le cose sarebbero in grado di determinare in noi delle rappresentazioni di natura completamente diversa dalla propria.
Ponendo un’equivalenza strettissima fra movimento, immagine e materia, Bergson sembra contrapporre alla soluzione fenomenologia – ogni coscienza è coscienza di qualcosa – un affermazione ben più radicale, per la quale ogni coscienza è qualche cosa. La coscienza intenzionale non avrebbe dunque alcun privilegio ontologico rispetto alle cose percepite: la percezione si fa nelle cose, “là dove esse sono”, e caso mai bisognerà spiegare il modo in cui, da un universo preindividuale di materia in movimento possa nascere una coscienza individuale. Si tratta di due uscite possibili dalle difficoltà del dualismo psicologico, ma che evidentemente vanno in direzioni opposte: da qui anche la forti critiche che Bergson ha costantemente ricevuto da parte della fenomenologia francese e la relativa marginalità di cui ha sofferto il suo pensiero all’interno del panorama filosofico del XX secolo.
Tuttavia, il punto più importante ai fini del nostro discorso è che l’ipotesi bergsoniana permette a Deleuze di partire, nella sua analisi del cinema, da un assunto di fondo davvero audace, ovvero che la nostra realtà è letteralmente un universo cinematografico, fatto di immagini, o – ribaltando i termini dell’identità – che il cinema è la realtà. Non c’è alcun problema di rappresentazione nel cinema, caso mai di creazione: il cinema è capace di creare direttamente il movimento reale, laddove invece le altre forme d’arte visuale ricorrono a immagini statiche, come la pittura, la scultura e la fotografia, o a movimenti astratti, come il teatro. Nel cinema, esattamente come nell’ipotesi bergsoniana, le cose si differenziano all’interno del tempo e si determinano nello spazio: è l’immagine-movimento, che indica un movimento reale in una durata concreta, fatta valere contro l’immagine del movimento, classicamente concepita come una rappresentazione attraverso sezioni immobili in un tempo astratto. Questa distinzione è evidente fin dal titolo dei due lavori, dove immagine-movimento e immagine-tempo sono scritti col trattino, a voler eliminare la distanza semantica che li separa.
L’equivalenza fra immagine, materia e movimento è pensabile solo se rinunciamo a porci dal punto di vista della coscienza per sposare quello della materia. Un universo così concepito, infatti, è chiaramente preindividuale: non è possibile porre alcuna gerarchia spaziale né temporale all’interno di esso, nessuna divisione tra soggetto e oggetto, “non c’è mobile che si distingua dal movimento eseguito, non c’è mosso che si distingua dal movimento ricevuto”[1]. Le immagini agiscono le une sulle le altre in un continuo scambio, anzi, sono le immagini stesse a essere azione e reazione in tutte le loro parti, formando una sorta di materia-flusso in perenne vibrazione senza alcun riferimento stabile: il corpo, il cervello, sono immagini fra le altre. Deleuze definisce l’immagine-movimento un piano di immanenza, l’in sé dell’immagine, dietro la quale non è nascosta alcuna realtà ulteriore: è attualizzazione pura, puro movimento privo di qualsiasi virtualità.
È evidente che un tale insieme di immagini non richiede alcun occhio che le percepisce, poiché esso è, in se stesso, pura luce, luminosità diffusa che si propaga senza mai né rifrangersi ne riflettersi. Questi ultimi concetti infatti sono adatti a una realtà concepita attraverso la giustapposizione di corpi solidi, ma non hanno significato in un universo di immagini-movimento. Il piano di immanenza non conosce né alto né basso, né destra né sinistra, l’occhio è privato della sua funzione percettiva, essendo a sua volta un’immagine fra le altre.
In realtà non viene negata la possibilità della percezione, ma solo della percezione soggettiva e individuale. Infatti le immagini percepiscono il movimento nella misura in cui lo ricevono e ne vengono influenzate in tutte le loro parti: esse danno luogo a una “percezione totale”.
Di conseguenza, non si tratta di aggiungere qualcosa per passare dalla percezione diffusa a quella cosciente, ma di sottrarre al movimento delle parti, di selezionare e isolare delle immagini. Tale isolamento non comporta una differenza di natura tra le immagini che Bergson chiama “viventi” e le altre immagini, ma solo un differimento temporale tra l’azione e la reazione. L’affermazione citata poco fa, per cui una corretta comprensione di un oggetto non è quella che lo considera come una cosa, ma quella che permette di isolarlo dal contesto come un quadro, sembra proprio trovare il suo naturale correlato nella procedura cinematografica più elementare, quella appunto dell’inquadratura. L’inquadratura infatti non cambia nulla nel flusso delle immagini, semplicemente ne seleziona una, la isola, e fa sì che essa diventi un “centro di indeterminazione” rispetto al quale tutte le altre immagini si organizzano spazialmente e cronologicamente. L’immagine inquadrata, quella che Deleuze chiama immagine-percezione, è quella che permette l’esistenza di un centro, di un soggetto, di un sistema di riferimento delle immagini. Anzi di un doppio sistema di riferimento dell’immagine, quello assoluto e quello che varia in funzione di essa.
L’inquadratura costituisce lo scarto, l’esitazione tra l’eccitazione e la risposta. Tuttavia questa sospensione non è fine a stessa, ma mira all’attività consapevole – che si distingue così dalla reazione immediata – della coscienza: determinando l’orizzonte del mondo attorno a sé, l’immagine-percezione permette una valutazione delle immagini percepite in funzione dell’utilità pratica dell’azione. La reazione ritardata diventa quindi immagine-azione, il momento in cui si sceglie quale azione intraprendere nel novero di quelle possibili. Ma se l’immagine-percezione è quella che apre lo scarto fra stimolo e reazione e l’immagine-azione quello che lo chiude, c’è un terzo tipo di immagine cinematografica che riempie tale scarto: è l’immagine-affezione, cui Deleuze dedica ben due capitoli di L’immagine-movimento.
L’affetto espresso nell’immagine affezione è una qualità intensiva dell’immagine, e anche potenza, potenzializzazione dello spazio. L’immagine-affezione definisce il centro di indeterminazione nel suo aspetto intensivo, laddove l’immagine-percezione e l’immagine-azione ne tracciano i limiti estensivi. Nel cinema questa immagine corrisponde al primo piano, o al dettaglio, quell’elemento che viene astratto dal flusso delle immagini in intensità, come une elemento saliente.
L’immagine-affezione, intensiva, si caratterizzava temporalmente già nella sua dimensione di esitazione, determinata dall’emergere di tutte le risposte possibili in virtù di uno stimolo ricevuto. Proprio perché va a riempire una sospensione nel continuum delle immagini-movimento, essa si configura come una singolarità, l’emergere di un affetto puro in un intervallo spazio-temporale. A partire dalla divisione dell’inquadratura in tre tipi di immagini (percezione, affezione e azione) il cinema è in grado di produrre una prima e fondamentale immagine indiretta del tempo, attraverso il procedimento del montaggio cinematografico. “Il montaggio è la determinazione del Tutto”[2]. In un film, qualcosa accade, così che la situazione di partenza viene modificata attraverso un’azione per ottenere una situazione finale differente. In altre parole, a partire dalle distinzioni tra queste tre forme di immagine movimento, percezione azione e affezione, si determina una narrazione, una configurazione di senso.
Sarebbe riduttivo pensare che il cinema in qualche modo vada inteso come una metafora di quanto avviene sul piano ontologico. Più che altro indica un percorso di lavoro alla filosofia. Tale percorso dovrebbe essere quello di provare a individuare i principi genetici delle configurazioni di senso del reale, anziché limitarci alle comprensione del loro funzionamento logico epistemologico a posteriori
[1] Ivi, p. 76
[2] Ivi, p. 44.