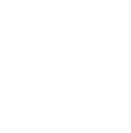Colloqui sull’individuo 6. Il soggetto allo specchio 12 giugno 2016
Colloqui sull’individuo 6. Il soggetto allo specchio 12 giugno 2016
- Agostino è un autore famoso certamente per le “Confessioni” ma che in effetti andrebbe letto in modo organico. Si tratta di un autore fra i più prolifici della storia. Le sole opere principali sono 96 ma se ne contano oltre 300.
- La prima questione che andrebbe affrontata riguarda ovviamente il legame di Agostino con il Cristianesimo che non è di tipo poi così scontato. Agostino Trapè, il massimo curatore delle “Confessioni”, ha sostenuto che “Non è Agostino che si rispecchia nel Cristianesimo ma dopo di lui è il cristianesimo che si rispecchia in Agostino”. In questa conversazione cercheremo di vedere quanto, specialmente con la sensibilità dei nostri tempi, tale osservazione possa costituire una buona indicazione di lettura della concezione agostiniana della coscienza.
- L’espressione “Confessio”, da cum-loquor fa esplicito riferimento a un discorso con qualcuno; ma presa così l’affermazione è superficiale. Ad un’analisi più attenta al cum piuttosto che al loquor, ci si accorge che le “Confessioni” sono sia un monologo sia un soliloquio. La differenza è essenziale sia in Teatro sia in generale nella letteratura.
- Come si intrecciano la dimensione monologica e quella del soliloquio è uno degli aspetti che cercheremo di discutere: il momento del monologo emerge, come accade in qualunque forma teatrale, laddove Agostino, per l’appunto mette in scena il suo Io, la sua anima, la sua psiche. E’ una Mise en Scène (è un concetto tipico della cultura teatrale che in senso lato si può definire preparazione di eventi coordinati prima della loro realizzazione effettiva). L’intreccio delle “Confessioni” è una Mise en Scène scopertamente retorica ma di importanza enorme perché, come lo stesso Agostino dice nel “De Doctrina Christiana” il proferre, l’uso della retorica classica può condurre a una nuova retorica cristiana. L’altra riflessione che emerge è di carattere linguistico-culturale e consiste nella differenza tra res (la cosa in sé) e signum (ciò che rimanda ad altro). La parola è sicuramente un segno, afferma Agostino. Dunque è Monologo quando vuole indurre alla riflessione, quando mette in scena l’io del quale parla, quando, cioè oggettiva il sé pensante nella forma della riflessione. E’ la costruzione di un tessuto complesso, su base autobiografica che mette in scena l’anima, le permette di muoversi, le conferisce spazio comunicativo.
- Diciamolo, senza la storia appassionata della sua vita, come avrebbe potuto seriamente far parlare l’anima? Ecco perché è come costretto dalla stessa forza delle sue idee a seguire dall’inizio alla fine un protocollo comunicativo tipico del monologo, perché il lettore sia chiamato in causa, cosa che vuol dire, inesorabilmente e sempre, essere messo davanti a una storia.
- Dunque la dimensione del monologo viene incontro a uno sdoppiamento canonico: da un lato l’autore dall’altro il lettore/spettatore dove l’oggetto è la storia di un’anima che cerca Dio. Dio, in quanto tale, non c’è; è solo (si fa per dire) il termine della storia; è il punto di fuga. Parlo della mia storia perché la mia storia è quella della tua Ma Dio, in effetti, in questa storia parla solo ed esclusivamente attraverso i suoi testi, le centinaia e centinaia di citazioni bibliche ed evangeliche che costituiscono i segni di Dio. Non Dio.
- Eppure Dio c’è. Ed è questo il vero fascino delle “Confessioni”. E non si cada nel facile tranello che Dio c’è perché non lo si raggiunge; dico questo perché se impostassimo così la lettura del rapporto coscienza-Dio faremmo un torto all’intelligenza di Agostino. Dio non lo si raggiunge perché è il punto di partenza e qualunque grande scrittore di teatro lo sa; forse si parlerà di Amleto. Bene Amleto sa subito, immediatamente che è un fantasma che ha il suo stesso nome a muoverlo e che tutto parte da una presenza sdoppiante, ossessiva, etimologicamente catastrofica (cioè capace di katastrophè). Ma in genere tutte le opere che presentano una struttura monologico-ossessiva partono da e arrivano a lo stesso punto. Dunque è dilettantesco sostenere che Agostino scrive un’opera nella quale egli cerca Dio in se stesso; dilettantesco e poco riguardoso della sostanza del discorso che sta rivolgendosi a un vero e proprio pubblico. La Mise en Scène è la vita. Dio è il termine del protocollo, è la persona alla quale ci si rivolge ma in realtà non è dentro ma fuori; ed è fuori semplicemente perché la narrazione ne parla. Ma non parla (ça parle)
- Ma questa presenza è la presenza monologica; non è lo stesso per l’abisso del soliloquio ed è qui che Agostino gioca la sua vera partita con Dio. Qui vexilla regis prodeunt inferni potremmo dire ereticamente. E la gioca non perché Parla di Dio ma perché Dio parla. Se l’inconscio freudiano parla,ça parle direbbe Lacan, è perché ha qualcosa da dire, e questo qualcosa si colloca a livello del non sapere: l’individuo parlante non sa cosa dice. Ed ecco che ci troviamo già catapultati nella questione chiave del problema: noi di Dio sappiamo qualcosa?
- Né sappiamo qualcosa né abbiamo il diritto di nominare il qualcosa; in noi quando scatta il soliloquio scatta perché siamo soli. Troppo facile dire che lo dice la parole stessa ma è esattamente così. Quanto il desiderio di felicità, il Desiderium ultra solem. Le analogie di questo percorso agostiniano con quello cartesiano si sa sono molte. Anche Cartesio accetta la sfida del soliloquio ma lo fa sostenendo di cercare il fundamentum inconcussumche viene identificato nel cogito e questo, in quanto ‘Io’, viene ricondotto a ‘Dio’ come luogo di partenza e di arrivo.
- E così come il compito dell’analista diciamo lacaniano non sarà quello di riconnettere l’inizio alla fine, di conciliare l’Io e la sua immagine, di richiudere una faglia, magari con la pretesa che una totale ri-significazione della propria storia sia sufficiente ad annullare questa frattura strutturale, questa Spaltung, scissione soggettiva, allo stesso modo Agostino lascia che l’Altro parli nella sua coscienza. Vediamo se è vero e vediamo come. Ci si è mai chiesti in termini non-teologici perché le questioni della creazione sono alla fine e non all’inizio delle “Confessioni”? Perché lì Agostino non produce più il monologo ma è solo con se stesso, è nella dimensione del soliloquio. Si è spogliato della macchina scenica. Parla Dio perché parla il logos. Logicamente affronta le questioni che sono, sì, di principio ma che proprio perché sono di principio devono essere trattate alla fine e non, si badi, per un facile gioco di distinzione fra cominciamento e principio. No. Troppo comodo. Già Aristotele se ne era lamentato non nel IV ma nel V della Metafisica.
- Il principio è alla fine perché il principio non ha cominciamento, non ha dimostrazione, non ha spazio se non quello ipotizzabile o per Anfibolia (Kant, substantia phaenomenon dell’Analitica Trascendentale) o, meglio, per Aufhebung (Hegel). Sicché quando Agostino ammette la perenne inquietudine del nostro cuore (Et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te) sta trattando il tema dell’Altro, dell’indicibile, della presenza devastante che non si può prendere né con il logos perì tès ousias di Aristotele e neppure con l’idea di Bene. La presenza che ogni tanto avverte, che ogni tanto emerge come honor-horror è Dio e dunque è possibile un soliloquio. Il Dio del quale sente in sé Agostino la presenza non è evanescente fa essere noi evanescenti davanti a lui. Questo è il problema; ed è puntualmente dentro il soliloquio che la coscienza scopre quanto siamo fragili, non nel monologo. Il monologo è forte, il soliloquio è fragile. E’ nella fine, nel viaggio alle radici del principio che Agostino comprende che noi siamo fatti a Te ex Nihilo, partendo da una massa informe et incomposita, un prope nihil.
- Nelle “Confessioni” Agostino fa conoscenza con l’altro assoluto, con quella luce-buio che fonda la mistica cristiana ed è proprio per questo che monsignor Trapè molto probabilmente ha visto giusto. Qui non è in ballo tanto il corpus dottrinale cristiano che certamente si è giovato dell’opera quasi sterminata di Agostino, quanto l’atteggiamento di assoluta solitudine del rapporto uomo-Dio attraverso il logos. Non è più e non sarà mai più il logos perì tès ousias aristotelico e neppure l’eidos, l’idea platonica. Ormai con le “Confessioni” il logos parla dentro la coscienza; per forza i moderni, Lutero e Cartesio tornano su Agostino perché il soggetto – coscienza e il logos, nel grande pensatore africano sono arrivati alla tragedia della loro reciprocazione infinita. L’infinito principio e il misero cominciamento della nostra vita. “Sei nato?” – dice Agostino- “ne morrai”. Morrai di vita perché nascendo hai contratto la vita. Ma nascendo, defluendo in questo mondo, hai pensato e così come si muore da soli, si pensa da soli. Così facendo Agostino chiude la lunga stagione della gnosi, quella che da Clemente Alessandrino in poi e dopo tanti altri si era snodata rispetto al tema del logos: Chi è? Cos’è? quando e come agisce in noi? Qual è il suo potere? Questa serie di interrogativi viene assunta risolta in buona parte proprio nelle “Confessioni”: non è il logos a generare la comprensione, ma la comprensione a parlare in una lingua che noi chiamiamo logos. L’inversione si è compiuta. Da quel momento è il cristianesimo che da questo punto di vista si rispecchia in Agostino.
- Da: Angelo Silesio, pseudonimo di Johannes Scheffler, “Il viandante cherubico”, composto presumibilmente nel 1674 (I, 72)
“Dio abita in una luce che non si raggiunge attraverso nessuna strada / Chi non diventa a sua volta una luce, non lo vede in eterno.
(Gott wohnt in einem Licht, zu dem die Bahn gebricht:
Wer es nicht selber wird, der sieht ihn ewig nicht)