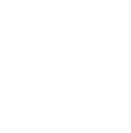L’impossibile, il possibile, l’assurdo – Dell’insegnamento
 Beatrice Bonato
Beatrice Bonato
Lezione dell’8 aprile 2018 alla Scuola di Filosofia di Trieste https://scuolafilosofia.wordpress.com/
Equivocità dell’impossibile 1
Partirò da una domanda preliminare: cosa tiene insieme i tre impossibili nominati da Freud? Perché proprio quelli e non altri? Ѐ come se, in forma negativa, associandoli cioè nella comune impossibilità, Freud pensasse a un’affinità tra essi. Ciò che li accomuna, in altre parole, non può essere semplicemente il fatto che sono – ammesso che lo siano – tutti impossibili.
Mi sembra sia qui sottintesa l’idea che il compito comune al governo, alla psicoanalisi, all’insegnamento, sia talmente ambizioso, elevato, esigente, da dover entrare in conflitto con i limiti e gli ostacoli incontrati nell’esperienza effettiva. Quindi prima di tutto credo si tratti di portare alla luce questa idea sottintesa. Ѐ facile capire che si tratta del proposito di rendere gli esseri umani migliori e più felici, nel senso classico della parola, attraverso la guida di qualcun altro che si trovi in una posizione caratterizzata da una certa superiorità, per quanto relativa. Si capisce allora molto bene perché, se questo è l’ideale sotteso alla politica, dal punto di osservazione in cui Freud viene a trovarsi non ci possano essere illusioni sulla “possibilità” della politica.
Ci sarebbe già molto da discutere sulla sotterranea parentela che permane, sotto il velo dell’impossibilità, tra essa e il governo. E che dire dunque dell’insegnamento? Prima di stabilire se sia o non sia impossibile, dovremmo sapere almeno vagamente cosa intendiamo con questa parola. Cosa ha in comune l’insegnamento con la psicoanalisi? Non molto, credo. E con l’attività di governo? In questo caso la questione è più complicata. Il legame è certo più stretto: il potere che si esercita nella pretesa di istruire, educare, formare i giovani, e che si risolve in una richiesta di esecuzione di compiti, di adattamenti vari, di risposte in fin dei conti obbedienti e disciplinate, richiama da vicino il potere politico.
Fatta quest’ammissione, però, vorrei provare a “slegare” l’insegnamento dal governo. L’impossibile dell’insegnamento, insomma, porterebbe lontano dall’associazione con la politica. Soprattutto lontano da una politica che pretenda di determinare cosa sia insegnamento e cosa ci sia da apprendere e da non apprendere, da sapere e da non sapere.
Terrò presente come primo riferimento le analisi di Jacques Derrida e di Pier Aldo Rovatti in L’Università senza condizione.[2] In questo scritto del 2001 viene già denunciata una tendenza in atto nell’università; è chiaro al tempo stesso l’intento di opporsi a essa. Ci si chiede che cosa ne sia della libertà nell’insegnamento a fronte a condizioni sempre più numerose e minuziose. Quel discorso resta a mio avviso perfettamente attuale. Oggi, semmai, gli spazi di libertà sottratti ai condizionamenti e alle condizioni, cioè, nei termini derridiani, gli spazi per l’impossibile, si vanno restringendo.
Non vorrei insistere troppo sulle critiche al modello di scuola e di insegnamento che si va diffondendo e imponendo, né soffermarmi su dettagli poco comprensibili per chi non lavora nella scuola. Se si vuole però averne un’idea, può essere d’aiuto leggere qualche paragrafo del nuovo documento della commissione istituita dal MIUR su filosofia e società della conoscenza, dedicato specificatamente all’insegnamento della filosofia.[3] Qui viene alla luce un progetto a mio avviso più definito di tanti altri interventi parziali attuati finora dalle riforme che hanno interessato la scuola. Siamo di fronte a una effettiva, forse convinta, e tuttavia per molti aspetti paradossale, valorizzazione della filosofia: le viene attribuito un peso molto maggiore che in precedenza, le si affida il compito di legare tra loro diversi saperi, ma al prezzo del suo pieno inserimento nel paradigma delle competenze.
Il potere politico disegna l’orizzonte della formazione generale dando alla filosofia un ruolo mai visto dai tempi, si potrebbe dire, della riforma Gentile. La filosofia al potere dunque? Forse sì, purché il potere dica cos’è e cosa deve fare la filosofia. Si dirà: ma non era in fondo questo il senso dell’educazione socratico-platonica? Penso proprio di no, se non altro perché quest’ultima avrebbe richiesto che i politici fossero “veramente” filosofi. Anche se lo fossero, tuttavia, credo che dovremmo sospettare di questa chiusura del cerchio sapere-potere. Anzi, dovremmo proprio cercare di spezzarlo.
Il documento citato prevede e programma tutto: cosa devono essere (e non essere più) la lezione, l’insegnante, soprattutto lo studente, del quale si deve tracciare il profilo in anticipo. Il possibile diviene sempre più ciò che deve essere pre-visto secondo condizioni sempre più dettagliatamente descritte e calcolate. Il possibile non è altro se non ciò che si deve poter monitorare lungo tutto il percorso, percorso nel quale sono sempre più rare le occasioni in cui potrebbe accadere qualcosa di diverso, in senso positivo o negativo.
A leggere bene, nelle decine di pagine del documento e dei suoi allegati si intuisce una battaglia tra quanti vorrebbero così salvare la filosofia e il suo specifico nell’insegnamento, e quanti invece sono interessati soprattutto ad armonizzare la sua presenza nel curriculum scolastico italiano con le indicazioni europee e con gli ultimi interventi legislativi nazionali. E tuttavia mi pare che il risultato sfiori l’assurdo. In questa situazione ci possiamo domandare se, per quanto riguarda l’insegnamento, e in particolare l’insegnamento filosofico nelle scuole, non sia il caso di salvare il possibile prima di dedicarci alla speculazione sull’impossibile.
Insomma, la questione sarebbe la seguente: è possibile che all’insegnamento sia lasciato uno spazio di libertà – la “condizione senza condizione”, ovvero la possibilità dell’impossibile nel senso derridiano – nonostante tutti i vincoli ai quali è sempre più difficile sfuggire? E che in parte esisteranno sempre in un’istituzione come quella scolastica, per il modo stesso in cui è concepita?
Suggerirei di cercare questa condizione di possibilità dell’insegnamento nella separazione, o almeno nell’allentamento del vincolo tra la cultura, la conoscenza, l’esercizio del pensiero da una parte, e l’addestramento obbediente ai dettami delle istituzioni politiche dall’altro. In termini politici, sarebbe il caso di sostenere l’opportunità di una limitazione degli interventi statali e sovrastatali nell’ambito dell’attività educativa, scolastica e universitaria, senza paura di essere accusati, per questo, di conservatorismo.
Chi deve diventare maggiorenne?
Tutti conosciamo la definizione kantiana di Illuminismo, come “uscita dell’uomo dallo stato di minorità che deve imputare a se stesso”.[4] Kant invita a pensare con la propria ragione, emancipandosi dall’autorità. L’invito rivoluzionario sembra attenuarsi alquanto tuttavia con la distinzione, fatta subito dopo, tra “uso privato” e “uso pubblico” della ragione. In un contesto “privato”, che Kant intende come quello dell’esercizio di una professione (amministrativa, militare, ecclesiastica), la ragione deve obbedire e il funzionario deve rinunciare alla critica; mentre nel suo uso pubblico, quando parla universalmente affrontando anche questioni ricollegabili alla professione che esercita, quando in altre parole veste i panni dell’intellettuale o del filosofo, egli non dovrà porre limite alla ragione. Dovrà parlare liberamente in suo nome. Il testo di Kant non prevede l’esempio dell’insegnante, del professore. Ma è evidente che proprio il caso del professore mette in luce i limiti e le contraddizioni dell’argomentazione kantiana. Soprattutto se si tratta del professore di filosofia. Che cosa insegna infatti un professore di filosofia, all’università ma pure in un liceo? L’oggetto di questo insegnamento non è forse l’esercizio libero della ragione? E come potrebbe essere coerente se accettasse il vincolo preventivo di farlo, per parte sua, solo nel caso dell’uso pubblico della medesima?
Prendiamo le prescrizioni contenute negli orientamenti sulla filosofia nella società della conoscenza. Immaginiamo che io le ritenga infondate per dei motivi sostanziali, non solo perché, ad esempio, irrealistiche – come in effetti sono, peraltro. Immaginiamo cioè che io non sia in alcun modo d’accordo con il fatto che la filosofia debba insegnare “competenze”. Che cosa dovrei fare? Verrei posta nella condizione imbarazzante di dovere, da un lato, obbedire ai miei superiori, dall’altro dichiarare pubblicamente l’insensatezza del progetto. Ma qual è il luogo per questo esercizio pubblico della ragione? Qualsiasi luogo fuorché la scuola?
Sembrerebbe di sì, stando a Kant. Resta però la domanda sull’ammissibilità di una dissociazione tra la parola pubblica, il dire il vero senza la preoccupazione di opporsi al potere, e il lavoro “privato” di insegnare ai giovani. Non voglio dire che sia un tema nuovo. La scuola che conosciamo è figlia della storia degli stati nazione moderni, e ha una funzione precisa in rapporto alle narrazioni legittimanti che gli stati hanno fatto di se stessi. Ѐ nata per creare, prima, fedeli sudditi, poi buoni cittadini, oggi cittadini competenti, il che non significa “cittadini dotati di competenze”, ma “competenti a essere cittadini”; come dire che l’essere cittadini dipenderà dalle competenze ritenute essenziali per ottenere quello status, e non sarà più una condizione politica.
Nella conferenza sullo scritto kantiano, Michel Foucault non ne ha trascurato le ambiguità, anzi le ha denunciate con chiarezza, invitando quindi a compiere un passo oltre il monito volto a distinguere le sfere pubblica e privata, a muoversi soltanto “entro il limite della ragione”. Se per Kant si era trattato di suggerire al potere statale un compromesso, obbedienza del funzionario in cambio di libertà di parola e di critica nell’arena pubblica, cosa che all’epoca non era cosa scontata, per Foucault il nostro tempo richiede semmai di spingersi a valicare il limite. Richiede un ethos filosofico caratterizzato in modo un po’ diverso da quello evocato dal testo kantiano:
“Questo έθος filosofico può essere caratterizzato come un atteggiamento limite. Non si tratta di un atteggiamento di rigetto. Dobbiamo sfuggire all’alternativa del fuori e del dentro; dobbiamo stare sulle frontiere. La critica è proprio l’analisi dei limiti e la riflessione su di essi. Ma, se la questione kantiana era di sapere quali siano i limiti che la conoscenza deve rinunciare a superare, mi sembra che, oggi, la questione critica debba essere ribaltata in positivo: qual è la parte di ciò che è singolare, contingente e dovuto a costrizioni arbitrarie in quello che ci è dato come universale, necessario e obbligatorio? Si tratta, insomma, di trasformare la critica esercitata nella forma della limitazione necessaria in una critica pratica nella forma di un superamento possibile.”[5]
Propongo di interpretare e tradurre tali indicazioni nel contesto del mio discorso sull’insegnare in questo modo: dovremmo salvare la possibilità di distinguere tra vincoli accettabili e prescrizioni arbitrarie, tra certi obblighi connaturati con il fatto di svolgere una professione dipendente, e l’invadenza da parte dell’agenzia da cui dipendiamo. E dovremmo trasmettere questa necessità di distinguere agli studenti. Non si può che condividere la raccomandazione foucaultiana a spostare l’attenzione dai limiti della ragione ai limiti del controllo sulla ragione. Il concetto in apparenza generico di “libertà di insegnamento”, del quale oggi ci si vorrebbe liberare, va inteso così. Se lo stato italiano legiferasse sui contenuti dell’insegnamento della filosofia ponendo per legge che si debba insegnare, per esempio, la filosofia orientale, questo rientrerebbe nelle sue competenze. Si dovrà fare in modo però che la filosofia orientale venga insegnata da chi la conosce. Ma se lo stato o altre agenzie da esso incaricate, stabilissero, qui ed ora, che si deve abbandonare la prospettiva storica e seguire quella delle competenze, o che i contenuti vanno calibrati e scelti in rapporto alle competenze da formare, allora avrebbero, credo, valicato i propri limiti. Non è facile, me ne rendo conto, tracciare il confine. Per fare un esempio più calzante: se chi ha l’autorità politica stabilisce che cos’è il pensiero critico (e lo identifica con il critical thinking, tecnica consistente nella capacità di snidare le fallacie logiche presenti in un discorso, oppure di smascherare le fake news) evidentemente il professore non potrà non reagire in nome della ragione e della stessa critica, che è ben più di una tecnica. Non potrà che reagire in nome di una critica che tocca le premesse, non solo i concatenamenti logici dei discorsi. Se il pensiero critico viene imposto secondo modalità che escludono, o vincolano in binari precostituiti, proprio l’esercizio critico a tutto campo capace di investire lo stesso diritto dell’autorità che lo impone, allora siamo di fronte a un circolo vizioso che andrebbe spezzato, o almeno messo in questione.
Autorità, trasmissione, disciplina
La posizione dell’insegnante non è innocente né neutrale rispetto all’esercizio dell’autorità. E l’esercizio critico della ragione contro l’autorità che Foucault suggeriva non può non estendersi agli studenti. Ma cosa succede quando la delegittimazione dell’autorità degli insegnanti da parte delle agenzie governative, delle autorità economiche, del sistema mediatico, si incontra con il tendenziale rifiuto dell’autorità da parte degli studenti, e con la derisione dei questa autorità?
Ѐ questo uno dei temi del libro di Bernard Stiegler Prendersi cura. Della gioventù e delle generazioni.[6]
Del libro di Stiegler mi interessa qui soprattutto la riflessione sul concetto di “disciplina”, nella sua articolazione con quelli di scrittura e di cura. Uno degli aspetti più problematici è costituito da una critica a quello che Foucault avrebbe trascurato nella sua ricerca sul rapporto tra potere, sapere, disciplinamento, controllo. Tale critica è imperniata sul mancato riconoscimento della complessità che si cela dietro il concetto e la realtà della disciplina. Di essa Foucault avrebbe visto solo il lato del controllo, del modellamento finalizzato ad abituare i soggetti all’obbedienza tramite l’interiorizzazione di pratiche ascetiche, perfezionate storicamente dal cristianesimo. Egli non si sarebbe reso conto, secondo Stiegler, del fatto che la dimensione ascetica ha sempre due lati, è quindi sempre ambivalente, sempre “farmacologica”: da una parte, tramite gli esercizi su se stessi si tende a prendersi cura di sé per la conoscenza di sé, dall’altra si forma una disposizione a obbedire, a se stessi ancora prima che ad altri. Oltre a questa ambivalenza la disciplina scolastica ha poi diverse dimensioni: disciplina è autocontrollo, esercizio su se stessi, riconoscimento di un’asimmetria tra studenti e docente che rende possibile il passaggio di un certo sapere tra le generazioni; disciplina è inoltre la cosiddetta “materia” di insegnamento, codificata come oggetto di trasmissione.[7]
Ai fini del mio ragionamento è utile sfruttare, anche a costo di una forzatura, questa prossimità di significato tra “disciplina” come “sapere” codificato, con suoi contenuti, regimi discorsivi, regole interne, soprattutto storia, che solo a queste condizioni può essere trasmesso (in un senso molto vicino a quello derridiano di scrittura) da una generazione all’altra, e la disciplina come autodisciplina e rispetto delle differenze generazionali e dei ruoli di chi insegna e di chi apprende. Come per esempio accade in un contesto scolastico, o anche universitario, si suppone.
Non credo si possa leggere in Stiegler un elogio della struttura tradizionale dei saperi né una difesa delle modalità tradizionali di insegnamento: il libro insiste infatti continuamente sulla centralità di un uso attivo delle tecnologie, e contro la loro demonizzazione da parte di diversi autori impregnati di un umanesimo malinteso. Stiegler d’altra parte ammonisce a non lasciarsi incantare né intimorire dall’ingiunzione a superare le discipline in nome di approcci interdisciplinari, innovativi, accattivanti, digitali. Mi viene in mente a questo proposito l’attuale enfasi sulle “prove esperte”, che sarebbero prove non di una singola disciplina, né di un gruppo di discipline affini convergenti su un tema. Le “prove esperte” chiedono di risolvere un problema simulando una situazione reale, che comporta competenze afferenti a diversi ambiti: quindi si correggeranno valutando le competenze, non le conoscenze né le capacità disciplinari. Come se non solo i docenti, ma anche le stesse discipline, fossero al servizio di qualcosa di più urgente e “reale”, il problema da risolvere. Si parla non a caso di “prove di realtà”. Molto sensato, si dirà. Tuttavia si tratta di un’arma a doppio taglio: da una parte si insiste giustamente sul legame tra la filosofia e i problemi della vita, dall’altra si riconducono e in ultima analisi si riducono i problemi della vita a problemi risolvibili con strategie di problem-solving.
Questo disegno non solo spezza il tessuto storico, lessicale, concettuale interno delle discipline – quello che ne resta, infatti, è al massimo la pura intelaiatura logica – ma insieme svaluta la disciplina dell’esercizio e derubrica quella del rispetto per la figura del docente di disciplina. Non è lui l’esperto, in altre parole. Che possa essere un intellettuale, o persino un pensatore critico, è completamente escluso. Egli diventa quindi inessenziale e altamente “fungibile”: un facilitatore, un tutor, un animatore di nuove strategie di apprendimento (flipped-classroom, debate, ecc., sulle quali si punta per il rinnovamento della didattica filosofica). C’è ben altro in gioco, quindi, rispetto a un progetto di miglioramento e ampliamento dei metodi didattici e di coinvolgimento attivo degli studenti, cose sulle quali è scontato essere d’accordo.
Detto per inciso, fino a quando gli insegnanti in carne ed ossa non saranno sostituiti da pochi docenti eccellenti in videconferenza o da altre modalità didattiche digitali, o da figure virtuali, ci sarà ampio spazio per lo stile e il carisma, esercitato nelle forme più diverse. Tutti sanno perfettamente che è ancora questo a fare la differenza, nel bene e nel male. Eppure la macchina sempre più minuziosa dell’organizzazione non è affatto messa in crisi da questa componente soggettiva, anzi, in un certo senso ne è rafforzata. Funziona sempre meglio grazie a questo lato oscuro dell’“autorevolezza” personale, che può persino diventare il mezzo per alcuni di conquistarsi zone franche e deroghe negate ai più. In altre parole, l’obbedienza da parte della maggioranza – nella scuola ma forse anche altrove – convive con la possibilità di smarcarsene da parte di pochi, i quali semplicemente si im-pongono, si sottraggono alle condizioni di assoggettamento della massa con le loro indubbie qualità. E quando ci si rende conto di avere, o di aver accumulato, un credito di questo tipo, è forte la tentazione di approfittarne per sfuggire alle maglie del sistema con qualche tipo di morbido ricatto.
L’impossibile e il potere
Il problema etico e politico è però che l’im-posizione, l’auto-posizione, per quanto fondamentale, non è ancora una opposizione, e spesso rischia di essere complice del potere. In altre parole, l’insegnante “eccezionale” diventa facilmente complice del dispositivo autoritario e omologante dal quale, per quanto lo riguarda, pretende di affrancarsi. Lo prende certamente in giro, lo elude, ma nel farlo gli fornisce vita e ne conferma la forza.
Anche queste osservazioni mi sembrano pertinenti rispetto alla questione dell’impossibile dell’insegnamento inteso come incalcolabile. Ne mettono però in luce un tratto inatteso, un risvolto indesiderato. Se l’impossibile, invece di incarnarsi in un’apertura alla relazione umana, al contatto tra generazioni lontane, nella scintilla che rinnova il sapere trasmesso, si presentasse invece nella figura dell’arbitrio, di una nuova forma di sovranità?
Voglio dire che ci potrebbero essere perversioni possibili dell’impossibile.
L’impossibile, scrive Derrida, è qualcosa che ci capita, ci cade addosso. Prendo un passaggio da Stati canaglia. Si parla di democrazia e di sovranità, il che sembrerebbe portarci fuori dal nostro tema. Ma Derrida rimanda espressamente a L’università senza condizione per far capire cosa intenda per impossibile.
“Questo im-possibile non è privativo. […] si annuncia a me, piomba su di me, mi precede e mi afferra qui adesso, in modo non virtualizzabile, in atto e non in potenza. Arriva su di me dall’alto, nella forma di un’ingiunzione che non attende all’orizzonte, che io non vedo venire, che non mi lascia in pace e non mi autorizza mai a rimandare a più tardi.”[8]
Certo, questo im-possibile è qui inteso come l’evento dell’altro, il non appropriabile. Eppure, le parole usate da Derrida – qualcosa che ci piomba addosso, a cui non possiamo sottrarci, che non ci consente rinvii, l’ingiunzione – non descrivono anche i tratti tipici dell’esperienza che facciamo del potere? E oggi precisamente del potere burocratico, governamentale, quell’inflessibile continuo flusso di ingiunzioni dall’alto da cui siamo letteralmente sopraffatti. In effetti non possiamo calcolarlo, né comprenderlo.
Autonomia e autoimmunità
Prendo spunto da questo testo di Derrida, ma si potrebbe farlo citando moltissimi altri luoghi nella sua opera, per riflettere su un’ultima questione, che sento fortemente implicata nella domanda sull’insegnamento oggi, e in particolar modo dell’insegnamento della filosofia.
Si tratta della questione dell’autonomia.
La parte conclusiva di Stati canaglia pone il problema dell’autoimmunità. Com’è noto, per Derrida l’autoimmunità è da intendersi come una certa capacità da parte della ragione, del soggetto, della democrazia, di abbassare, o sospendere, le proprie difese immunitarie per accogliere l’altro. Così rischia di suicidarsi, di morire come ragione, come soggetto, come democrazia. Come auto-nomia, nel senso kantiano di capacità di autodeterminarsi.
Insomma l’autoimmunità può richiedere la rinuncia all’autonomia. Ma il discorso di Derrida mi sembra qui piuttosto tormentato, sicuramente non univoco. Vediamo:
“Non esiste profilassi sicura contro l’autoimmunitario. […] Una transazione sempre rischiosa deve quindi inventare, ogni volta, in ogni situazione singolare, la propria legge e la propria norma, ossia una massima che accolga ogni volta l’evento a venire. Non c’è responsabilità né decisione, ammesso che ve ne siano, che a questo prezzo. […]
Se un evento degno di questo nome deve arrivare, è necessario, al di là di qualsiasi controllo, che agisca su una passività. Esso deve colpire una vulnerabilità esposta, senza immunità assoluta […]
Da questo punto di vista, l’autoimmunità non è un male assoluto. […] Senza autoimmunità, con l’immunità assoluta, più nulla capiterebbe. […]
Ciò che occorre pensare, qui, è questa cosa inconcepibile o inconoscibile, una libertà che non sia più il potere di un soggetto, una libertà senza autonomia, una eteronomia senza schiavitù, insomma qualcosa come una decisione passiva.” [9]
Voglio sottolineare soprattutto la frase “l’autoimmunità non è un male assoluto”: non è detto dunque che sia un bene assoluto, né che sia sempre un bene. Qui c’è la stessa difficoltà, lo stesso rischio di un pervertimento totale della mossa che Derrida cerca di fare e ci suggerisce di fare. Perché esporsi, lasciar perdere l’autonomia, e nello stesso tempo farlo liberamente, è esattamente quello che ci viene richiesto, comandato. Perciò, a costo di mantenere una certa cautela verso l’esposizione autoimmunitaria, mi arrischio a proporre che l’autonomia, come concetto e come condotta pratica, vada rilanciata. Oggi essa non ci appare tanto come una tutela della nostra identità contro l’alterità e la differenza, ma piuttosto come la difesa dell’onore della ragione, per evocare un’altra bellissima immagine derridiana, quella del capitano della nave che deve scegliere se affondare o far incagliare la nave.[10]
Non si tratta, mi pare, di salvare l’onore a costo dell’affondamento. Perché non cercare di salvare l’onore e la vita della nave? Certo, forse è impossibile, ma, appunto…
Nell’insegnamento, di fronte all’invadenza dello stato, del proliferare delle agenzie formative e valutative, per me non c’è altra strada che difendere proprio l’autonomia, senza la quale la libertà d’insegnamento è un’espressione vuota. Parlo dell’autonomia della ragione ovviamente, non della licenza di eludere i compiti a cui si è tenuti per la propria professione.
L’autonomia della ragione ci riporta dunque allo scritto kantiano sull’Illuminismo, per oltrepassarlo nel senso mostrato da Foucault.
L’autonomia della ragione non si regge però da sola. Occorre riconoscere che richiede l’esercizio da parte dei singoli di un certo coraggio. Anche semplicemente per accettare di apparire all’opinione pubblica in veste di “resistenti”, per usare una parola che non gode oggi di una buona fama.
Non si può trascurare, nel farlo, un’obiezione spesso rivolta a chi insegna nelle scuole. Quello che difendete, ci viene detto, non è altro che una serie di rituali, regole, contenuti e valori autoreferenziali, caratteristici di un sistema che non dialoga da tempo con null’altro che con se stesso, chiuso al resto del mondo, del lavoro come della cultura, un selfish system, come scrive Sloterdijk in Devi cambiare la tua vita.[11] Oggi la scuola “sforna ogni anno coorti di studenti” che non sanno nulla che non sia “scolastico”; non hanno cultura, non sono personalità, ma neppure sono buoni cittadini.[12] Non è sempre stato così. La scuola moderna è vissuta a lungo in una condizione di ambiguità, accentuatasi nel momento in cui gli stati nazionali decisero di prendere in mano l’istruzione, ai fini della formazione dei cittadini. Fingendo di adattarsi alla nuova situazione la scuola, istituzione nata con una diversa vocazione – coltivare quella forma di eccesso lussuoso, elevato e “inutile” che è, appunto, la cultura – avrebbe continuato a farlo protetta dalle sue mura, in un certo senso ingannando lo stato. Sloterdijk definisce “maladattamento creativo”questo patto ambiguo tra stato e scuola.[13] Nel XX secolo lo stato ha manifestato con maggiore forza l’intenzione di riprendere il controllo, mentre la scuola d’élite si trasformava in scuola di massa. Il maladattamento tuttavia permane, ma diventa “maligno”. Finisce per celebrare riti: la lezione, l’interrogazione, l’esame. C’è qualche soluzione? Anche se non si sbilancia ma si mantiene sul piano della diagnosi, Sloterdijk sembra guardare con interesse alle proposte radicali di chi oppone la rete alla scuola, in un esercizio quasi di purificazione da compiersi attraverso “l’inselvatichimento dell’intelligenza”, la “pedagogia della giungla”: “In questo contesto, sono notevoli i dati secondo i quali, nei giovani che trascorrono molto tempo giocando al computer ed esponendosi alla comunicazione-spazzatura, sono osservabili elevati effetti di allenamento nell’intelligente relazione con l’immondizia digitale”.[14]
Se volessimo interrogarlo sull’impossibile, si può supporre che Sloterdijk ne cercherebbe le tracce in questo fuori assoluto rispetto alla scuola e all’insegnamento scolastico. L’allenamento scolastico infatti, a suo avviso, non allena a nulla, perché ha perduto il rapporto con il senso dell’esercizio come automiglioramento, come acrobatica.
La lezione, la parola
Ѐ una critica da prendere sul serio. Nello stesso tempo andrebbe corretta in punto decisivo. Gli stati non sono così sprovveduti e da tempo si muovono verso un recupero del controllo del sistema scolastico. E lo stanno facendo, almeno in Italia, attraverso un’azione sistematica di investimenti sul digitale e sull’inselvatichimento nella rete, mentre contemporaneamente insistono sulla necessità di seguire in modo sempre più minuzioso i comportamenti in rete degli studenti. Sono chiaramente tutti progetti ortopedici che ovviamente, dal punto di vista delle agenzie che li elaborano, devono operare sul campo. La lezione “frontale”, tipica forma dell’insegnamento tradizionale, viene invece screditata come pratica scolastica.
Eppure è quello il momento, insieme a qualche altra eccezionale occasione quale può essere un colloquio personale, libero e non provocato, oppure uno scritto, in cui è possibile, talvolta, lasciare un segno, in-segnare. Anche se il più delle volte niente di tutto ciò accade. Ѐ sempre più chiaro, almeno per me, che i momenti in cui qualcosa passa, da noi agli studenti, sono quelli in cui l’esposizione, la spiegazione, o come si voglia chiamarla, si vivifica per l’intervento non programmabile di una componente personale, nostra o di qualche studente.
Certo si può recitare, e a molti non manca il talento né mancano le istruzioni per l’uso. I conferenzieri più smaliziati hanno imparato da tempo e per fortuna a lasciare perdere le slide – o meglio le usano solo come sfondi evocativi. Sanno anche molto bene quando inserire l’aneddoto, la battuta. Quello che passa, che “tocca”, torna dunque a essere la parola, che va dal singolo ai molti. Per capire la tendenza basta guardare i Ted Talks, modello di comunicazione di conoscenze all’avanguardia. La differenza tra esso e la lezione è solo nella brevità e nella padronanza delle strategie comunicative.
La mia impressione è che siamo di fronte a un ritorno forte della parola che mira a insegnare, a lasciare un segno emancipandosi dall’immagine e dalla scrittura, in qualche modo ristabilendo una padronanza su di esse. Ma tutto ciò avviene fuori dalla scuola. E perché? Perché alla scuola si chiede di addestrare. L’eccedenza creativa, insomma, si vada a cercarla altrove.
Ora, si tratta di un ritorno della parola efficace, persuasiva; la parola che affascina, che esercita potere. La parola sofistica, si potrebbe dire. Dove ogni effetto è calcolato, soprattutto l’autoironia, e non è mai spinto troppo oltre. Una simulazione perfetta, che si realizza in una cornice autorevole.
Forse l’impossibile nell’insegnamento, dell’insegnamento, consiste anche nell’infrangere il velo di questa messinscena, in uno strappo vero, in una comunicazione non totalmente costruita ma aderente a un’attività di pensiero. Un momento di verità, sottratto agli imperativi dell’efficienza ma anche al narcisismo personale; possibilmente senza che tutto ciò trapassi nel patetico, risolvendosi in un fallimento. Più modestamente e con maggiore realismo si può dire che ogni tanto ci si dimentica di recitare e si parla, semplicemente, e parlando si parla di qualcosa a qualcuno. Non è detto però che i destinatari abbiano la stessa percezione.
Fantasmi
L’esercizio sull’impossibile non può concludersi qui, lo capisco bene. Perché, anche quando la scuola fosse il paradiso della libertà di insegnamento e del confronto tra persone che studiano e discutono, anziché doversi preoccupare di predisporre moduli e schede ecc., i problemi fondamentali resterebbero ancora senza risposta.
L’impossibile dell’insegnamento scolastico sta anche, come accennavo sopra, in altre difficoltà non del tutto eliminabili. Ho accennato alla questione della disciplina che ogni intervento educativo comporta; per non dire del problema della valutazione, che rimane ineludibile al netto delle critiche; soprattutto però penso a quello che succede, e il più delle volte non succede, nel passaggio delle parole tra me e gli studenti.
Non credo ci sia qui in gioco soltanto un particolare “mal-adattamento” personale a una professione rispetto alla quale come molti sento una interiore distanza, e dove mi sembra di muovermi sempre in qualche modo alla cieca. Penso ci sia dell’altro. L’impossibilità di incontrarsi tra le generazioni, di scambiarsi esperienza e sapere. Il fatto che, mano a mano che diventiamo più consapevoli, ci allontaniamo dalla vita dei giovani. Cosicché, ciò che di meglio potremmo dar loro, arriva troppo tardi, non li raggiunge, perché manca un tempo comune. C’è una disgiunzione, un anacronismo, manca una cornice della comunicazione e della stessa esistenza. Manca un mondo presente comune. Questa impossibilità di un reciproco aggiustamento non mi pare ascrivibile tutta alle attuali politiche sulla scuola. Ѐ qualcosa che ha a che fare proprio con il processo della trasmissione e, ancora, con la pratica stessa dell’insegnare – nel senso del lasciare un segno nell’anima di qualcun altro. Forse questo è l’impossibile: una possibilità di cui non sapremo mai nulla, un incontro per il quale non esistono un tempo e un luogo. Un incontro mancato. Ѐ pur vero che, a nostra consolazione, dopo anni dalla fine del liceo, alcuni studenti vengono a salutarci e ci ringraziano per quello che abbiamo fatto: ma, appunto, tutto questo accade fuori tempo massimo, troppo tardi. Come se si incontrassero fantasmi.
[1] La lezione è stata tenuta nell’ambito del Cantiere Educare, coordinato da Pier Aldo Rovatti, in cui si è articolato il corso sui “tre impossibili” che Freud nomina nel saggio Analisi terminabile e interminabile: educare, governare, curare. Alla lezione è seguito un intenso dibattito con i corsisti, guidato da Annalisa De Carli. Programma, materiali e resoconti delle attività si trovano sul sito della Scuola di Filosofia https://scuolafilosofia.wordpress.com/
[2] J. Derrida, P.A. Rovatti, L’università senza condizione (2001), trad. di G. Berto, Cortina. Milano 2002. Vedi anche il fascicolo monografico di “aut aut” 358, La scuola impossibile, a cura di B. Bonato, il Saggiatore, Milano 2013 e il saggio di E. de Conciliis, Che cosa significa insegnare?, Cronopio, Napoli 2014.
[3] Il documento a cui mi riferisco si intitola “Orientamenti per l’apprendimento della filosofia nella società della conoscenza” e si può trovare, accompagnato da alcuni allegati, anche sul sito www.philolympia.org Mi pare condivisibile l’interpretazione che ne dà G Carosotti su “Roars”: https://www.roars.it/online/il-docente-di-filosofia-un-intellettuale-organico-della-buona-scuola/
[4] Kant, Risposta alla domanda: cos’è Illuminismo? (1784), in Scritti di storia, politica e diritto, trad. di F. Gonnelli, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 45-52.
[5] M. Foucault, “Che cos’è l’Illuminismo?” (1984), in Antologia. L’impazienza della libertà, trad. di V. Sorrentino, Feltrinelli, Milano 2005, pp. 229-230.
[6] B. Stiegler, Prendersi cura. Della gioventù e delle generazioni (2008), trad. di P. Vignola, Orthotes, Napoli-Salerno 2014. Rimando, per un’ampia analisi dedicata a questo libro di Stiegler al saggio di Eliana Villalta “Come un pesce volante”. La cura nell’epoca delle psicotecnologie con Bernard Stiegler appena pubblicato nel nuovo Quaderno di “Edizione”, Sulla cura. Pratiche e prospettive a confronto, Mimesis, Milano-Udine 2018.
[7] Stiegler ricollega, seppure in modo problematico, la disciplina al “potere di scrittura”, che a sua volta si lascia pensare secondo tre lati:
“[…] – come individuazione di un sistema di cura che regola i rapporti dell’individuo a sé e agli altri, ossia tra le generazioni, e che contiene quelle tecniche di sé attraverso cui si costituiscono gli oggetti di una skolé o di un otium;
– come transindividuazione di un sapere trasmissibile a quegli studiosi ordinari che sarebbero di cittadini di diritto di cui parlano Kant e Condorcet e che accedono al sapere mediante una disciplina che formalizza le conoscenze e che si insegna come tale;
-come dispositivo di sorveglianza, di controllo e individualizzazione, che può evidentemente condurre a una disindividuazione” (B. Stiegler, op. cit., pp. 238-23).
[8] J. Derrida, Stati canaglia (2003), trad. di L. Odello, Cortina, Milano 2003, pp. 127-128.
[9] Ivi, pp. 215-217.
[10] “L’incagliamento accidentale avviene, ovviamente, quando la nave, toccando il fondo, si arena accidentalmente. Questo incidente è un evento: capita […], capita perché, senza poterlo prevedere né calcolare, la nave affonda. […] L’incagliamento intenzionale, invece, avviene quando […] il capitano di una nave, poiché non riesce a mantenere la rotta, si prende la responsabilità di toccare il fondo – e anche questa decisione assomiglia a un evento. Tra l’incagliamento intenzionale e quello accidentale , sosterremmo lo sforzo disperato di salvare da un disastroso naufragio, nel peggior momento di una sconfitta confessata, ciò che resta dell’onore alla fine di una battaglia persa […] con la malinconica escatologia di una filosofia in lutto. Laddove non si può salvare nulla, si tenta allora di salvare l’onore della sconfitta. […] Filosofia in lutto […] o perché il mondo sarebbe sul punto di perdere la ragione […] oppure perché la ragione stessa […] sarebbe sul punto di divenire minacciosa; essa sarebbe un potere, avrebbe il potere di minacciarsi da sola, di perdere il senso dell’umanità e del mondo. Di perdersi da sola, di affondare da sola, preferirei dire di autoimmunizzarsi per designare questa strana logica per la quale un vivente può spontaneamente distruggere, in modo autonomo, ciò stesso che, in lui, è destinato a proteggerlo contro l’altro, contro l’intrusione aggressiva dell’altro. Perché parlare così di autoimmunità? Perché determinare in modo così ambiguo la minaccia […], l’incagliamento accidentale […] e l’incagliamento intenzionale […], ma anche la salvezza, il salvataggio, la salute o la sicurezza, come tante assicurazioni diabolicamente autoimmunitarie […]?” (ivi, pp. 171-177).
[11] P. Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita (2009), trad. di S. Franchini, Cortina, Milano 2010.
[12] Cfr. ivi, p. 531.
[13] Ivi, p. 530.
[14] Ivi, p. 532.