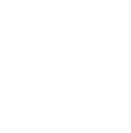FILOSOFIA IN CITTA’
FILOSOFIA IN CITTA’
Il coraggio della verità in Foucault
di Alice Pellicciotti
«[…] All’ultimo momento, gli si sciolse la lingua, e lui disse: “Critone, sono in debito di un gallo ad Asclepio”. Queste ridicole e terribili ultime parole significano per chi ha orecchie: “O Critone, la vita è una malattia!”. Possibile? Pessimista un uomo par suo, che vive serenamente e sotto gli occhi di tutti, come un soldato? Non s’era appunto preoccupato d’altro che di far buon viso alla vita, e per tutta la durata di essa aveva tenuto nascosto il suo giudizio ultimo, il suo più ultimo sentimento! Socrate, Socrate, ha sofferto della vita! E se ne è anche vendicato […]» (Friedrich Nietzsche, La Gaia Scienza – Aforisma 340)
Queste parole di Friedrich Nietzsche, riprese successivamente da Michel Foucault in uno dei suoi corsi, Il coraggio della verità, sono state il punto di partenza della questione affrontata durante il secondo incontro di “Filosofia in città 2018”, domenica 18 febbraio presso il Teatro San Giorgio a Udine. Per questo incontro, organizzato da Beatrice Bonato, sono stati scelti dei passi tratti da due opere di Nietzsche, La gaia scienza e La genealogia della morale, e da due testi di Foucault, Il coraggio della verità e Discorso e verità nell’antica Grecia, su cui hanno dialogato tra di loro e con il pubblico Sandro Chignola, professore ordinario di filosofia politica presso l’Università di Padova, e Raoul Kirchmayr, professore a contratto presso l’Università di Trieste dove insegna estetica e redattore della rivista “aut aut”. Tra le diverse letture, tre giovani diplomati presso il Conservatorio “Jacopo Tomadini” hanno deliziato il pubblico con due brani musicali, La nascita della tragedia e Dalla ruota al panopticon, composti da Felice Di Paolo e eseguiti dallo stesso Felice Di Paolo alle percussioni e da Nicola Fattori e Alessandra Rodaro ai corni.
La vicenda, assai celebre, della morte di Socrate lascia tutti perplessi. Socrate, colui che si dedicava a «l’esercizio della sua parresìa, che lo ha esposto alla morte, l’esercizio del suo dire-il-vero, e infine la sua dedizione nello spronare gli altri a occuparsi di sé stessi» (M. Foucault, Il coraggio della verità, pp. 116-117), sul letto di morte ammette di venire liberato da una malattia; Asclepio è infatti il dio che guarisce gli uomini. Ma quale? «La malattia da cui possiamo guarire quando ci occupiamo di noi stessi e quando siamo capaci di avere per noi stessi quella sollecitudine che ci fa sapere cos’è la nostra anima e in che modo è legata alla virtù» (ibidem): la vita. Questo passo, centrale nella tradizione filosofica, mette in luce una questione per cui è difficile trovare una risposta sicura: come si vive filosoficamente?
Michel Foucault, uno tra i più grandi filosofi della seconda metà del Novecento, prende a cuore questo interrogativo e, nei corsi tenuti al Collège de France dal 1971 al 1984, cerca di dare una risposta.
Quando Foucault lavora alla sua tesi si rifà all’Antropologia pragmatica di Immanuel Kant, il cui cardine è la condizione di finitezza dell’uomo. Ad essa è associata quella che Foucault definisce la morte dell’uomo teorico, in analogia con la morte di Dio in Nietzsche. La morte dell’uomo è la fine della parabola in cui il soggetto umano si presenta come disincarnato e come l’unico punto di vista sul mondo. Allora, con uno sguardo al mondo greco, bisogna ricercare delle modalità di soggettivazione in una situazione in cui il soggetto non è più quello filosofico, cioè il soggetto della conoscenza, ma è quello che si costituisce con la pratica e la tecnica. È bene precisare che “soggettività” non è “soggettivazione”, dal momento che la prima può ancora essere considerata una cosa, una posizione, un’identità, un punto fermo – è, in realtà, ancora un concetto filosofico -, mentre la seconda sposta interamente il discorso dall’essere al fare: è imprescindibile dall’iscriversi in una dimensione che è quella della pratica. Per Foucault al soggetto della teoria si deve contrapporre il soggetto etico che è finito e incarnato, inserito all’interno della trama di relazioni di potere ma insieme di relazioni portano ad una conoscenza di sé.
In questo contesto, allora, appare centrale la parola “parresìa” che spesso ricorre in Foucault. Cos’è la parresìa? È un atto di parola compiuto in un determinato momento, atto su cui si fonda il senso del vivere filosofico. In una relazione di potere chi parla mostra la volontà di contestare o modificare la relazione: essa è dunque una parola trasformativa (letteralmente “che muta qualcosa”) ed efficace, sia nel rapporto di potere sia su colui che la proferisce. Durante l’atto di parola, «parlare franco», parliamo con il cuore aperto, assumendo su noi stessi il rischio e il peso della messa in discussione del potere e nel contempo mettiamo in moto un cambiamento di noi stessi all’interno della relazione poiché ne va della nostra soggettività. Questa è una prassi che comporta tecniche racchiuse nella pratica dell’ascesi, intesa non nel senso mistico, ma nel processo e nell’esercizio che ci porta ad essere padroni della nostra interiorità.
La parresìa si lega alla parola “governo” in quanto atto politico, poiché senza questo atto di coraggio nella politica non c’è identificazione di sé, e alla parola “verità” che si profila come adeguamento di noi a noi stessi: nel vivere filosofico è necessario cercare, attraverso un processo di conoscenza di noi stessi, un secondo termine, una verità su di sé, a cui rivolgersi, cercando di realizzarla. Questo percorso richiede un maestro che sia in grado, dialogando, di metterci sulla pista della ricerca di una verità, dato che la parresìa è dipendente da un continuo gioco di relazioni. La verità è la scintilla che si produce nel contatto tra il maestro e l’allievo, e permette a quest’ultimo di dar luogo ad un discorso che non è niente altro che quello del maestro fatto proprio.
«Foucault rintraccia un’analoga relazione del maestro-allievo nel cristianesimo, in particolare nel binomio sacerdote-credente» spiega Raoul Kirchmayr. Dire il vero su di sé equivale, nel cristianesimo appunto, all’atto della confessione: essa si fonda su una relazione di potere, tra il confessore e il penitente, e implica che quest’ultimo esponga i suoi peccati senza mentire, rivolgendo uno sguardo severo alla propria anima. Avviene qui la trasformazione del soggetto in un soggetto morale, il “colpo di genio del cristianesimo”, come lo definisce Foucault, l’aver creato un soggetto infinitamente indebitato, la cui colpa corrisponde ad un debito, come nel gioco del potere. Ecco perché il potere pastorale può essere analizzato come una forma significativa del potere di governare gli uomini, dato che, mentre nel mondo greco attraverso un discorso si “costruiva” un’anima, nel mondo cristiano esso serve alla salvezza dell’anima. Ecco: «Vedete la parresìa è ora negligenza verso sé stessi, mentre prima era cura di sé» (M. Foucault, Il coraggio della verità, pp. 317). Centrale, come già affermato, diventa il mondo greco: il ritorno a esso permette di capire in primis il valore e il costo della parresìa ma anche di individuare i contenuti sedimentati che ci possono aiutare a districarci nella fitta trama dei rapporti di sapere – potere nel presente.
«Foucault fu un grande analista del potere, la cui definizione venne spesso fraintesa come un qualcosa che possa venire “tenuto”» incomincia Sandro Chignola, e per questo bisogna tenere presenti due istanze. La prima è che il potere non è una cosa fisicamente localizzata, non esiste un luogo del potere, non c’è un fuori rispetto ad esso, e questo è il principale problema. Il potere circola, invisibile, tra le relazioni. Servirebbe un catalizzatore per individuarlo dal momento che lo si può vedere solamente dove c’è qualcosa che gli resiste. In secondo luogo va ricordato che Foucault sviluppò il suo discorso facendo riferimento anche ad un altro testo di Kant: Che cos’è l’illuminismo? In questo breve saggio viene messa in gioco un’altra questione: che cos’è la critica filosofica dal momento che nemmeno la verità può esistere al di fuori del potere?
L’operazione del filosofo consiste nel porsi sul piano sagittale rispetto al tempo in cui appartiene, al fine di porlo in prospettiva storica e criticarlo (kantianamente parlando). È questo che Foucault riprende da Kant, grande pensatore della modernità: il fare oggetto della sua ricerca il presente a cui appartiene. «Siamo figli del nostro tempo» precisa il professor Chignola.
La “storicità” si è evoluta nel modo in cui il dotto è riuscito a darne una tracciatura analizzandone tutte le biforcazioni: è l’affermare che le cose sono andate così ma potevano andare in altri modi, dispiegando un campo di possibilità ancora a disposizione degli uomini nonostante la storia sia andata in un’altra direzione. In questa maniera si possono individuare le resistenze o i catalizzatori di potere maggiori.
Nei corsi sul mondo greco tenuti da Foucault, considerati il suo testamento politico, egli ha sottolineato quanto il potere si incarni sia in supplizio, tortura e prigionia, sia in capacità di controllare i corpi e renderli efficienti. Il rapporto tra potere e corpo è al contempo distruttivo e trasformativo.
Questo processo si può riscontrare nel capitalismo ottocentesco, dove un contadino veniva “trasformato” in un operaio cambiando la gestualità del primo secondo il codice di perfetta efficienza: da corpi improduttivi il potere li trasforma in produttivi, docili e utili.
Dagli anni Settanta del Novecento, con l’avvento del cosiddetto neoliberalismo, il potere tratta l’uomo come libero ma si ha a che fare con una libertà che alla fine viene governata. Veniamo in qualche modo trattati come individui da disciplinare ma apparentemente manteniamo la nostra libertà. Al giorno d’oggi, si può pensare ai social media e alla loro influenza. Il problema della soggettività in quest’epoca è che alla fine siamo comunque governati, esiste sempre il potere di uno su un altro; l’uomo, come diceva Aristotele, è un animale sociale e in quanto tale dipendente da relazioni sociali. Se il governo degli strumenti di potere, che permettono la manipolazione degli individui, si interfaccia con la libertà del soggetto, singolo, separato, qual è lo scopo della parresìa, del dire-il-vero?
Nel periodo storico in cui Foucault scrive emergono nuove resistenze al potere a livello globale: sono i movimenti anti-pastorali delle donne e degli omosessuali. Foucault stesso è omosessuale e a questo tema collega il concetto di parresìa. «Perché fare coming out? Molta gente ritiene l’omosessualità come un qualcosa che bisogna confessare a qualcuno affinché il potere riconosca dei diritti specifici, anche se non esistono dispositivi di confessione come nella cristianità» continua Sandro Chignola. Foucault ritiene che la parresìa non coincida con questa confessione di sé, funzionale al potere. Il problema di fondo, dunque, è una politica della soggettività che permetta di essere franchi, in primis, davanti a noi stessi, e che poi si trasforma in un parlare onesto nelle relazioni.
La morte di Socrate, da cui è partito il discorso della parresìa e da cui sembra derivare la constatazione che morire sia meglio che vivere, porta Foucault, che in quel momento, mentre teneva i suoi corsi a Parigi, sapeva anche lui di star morendo, a chiedersi se si può insegnare il coraggio. Di cosa? Non di morire, ma di vivere e di dire il vero, per trasformarsi e trasformare le relazioni di potere che ci circondano. Foucault sostiene ne Il coraggio della verità, che per vivere filosoficamente, e di conseguenza coraggiosamente, bisogna essere consonante tra parole e fatti. La filosofia deve dimostrare di non essere mera retorica e accompagnare i discorsi alle azioni, permettendo di vivere coerenti con ciò che si è.
In conclusione, il ruolo dell’intellettuale si colloca dentro un’etica della verità che attraverso le parole e i gesti deve essere trasmessa con l’essere franchi, con il dire la verità fino in fondo a qualsiasi prezzo, con l’affrontare chi detiene il potere smascherandone la nudità e infine con il fare una politica della filosofia.
«Sono un filosofo, non vi posso dire cosa fare ma voi sollevatevi e mi troverete al vostro fianco».