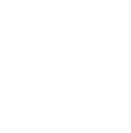A noi non potrà capitare
Sulla presunzione etnocentrica dell’Occidente
Claudio Tondo
I filosofi e l’epidemia. Reso possibile proprio dall’isolamento di queste ultime settimane, in rete e sulla stampa ha preso forma un intenso dibattito intellettuale sul significato filosofico della pandemia e sulle sue possibili conseguenze. L’urgenza è di riscrivere l’“ontologia del presente” come direbbe Michel Foucault. Un’urgenza incrementata dall’eccezionalità di un evento imprevisto o sottovalutato del quale attualmente ci sfugge il senso profondo e che contribuirà probabilmente a ridefinire le coordinate del mondo a venire. Nel farsi dell’evento e nell’impossibilità di collocarsi alla giusta distanza, il dibattito si è polarizzato in prevalenza attorno a due prospettive.
Compatibilità ecologica e giustizia sociale. Alcuni osservatori hanno sottolineato la possibilità che un fenomeno globale di così vasta portata possa provocare una svolta – già auspicata ma rimasta inespressa in occasione della crisi economica innescata dalla crisi finanziaria del 2008 – e che non sia né possibile né tantomeno desiderabile un ritorno alla condizione precedente. Questa lettura evidenzia, tra l’altro, l’idea secondo cui l’epidemia da Covid-19 sia un importante sintomo di una crisi ambientale di più ampia portata provocata dall’eccessiva pressione ecologica degli umani sul pianeta. In fin dei conti, ciò che gli umani “subiscono” dal virus non è molto diverso da ciò che essi, su un’altra scala, “infliggono” al pianeta. Tuttavia, è proprio dai virus che possiamo apprendere un lezione per una possibile via d’uscita: infatti, come per un virus la morte dell’ospite rappresenta una sconfitta evolutiva, allo stesso modo per Homo sapiens non è conveniente adottare strategie distruttive, tali da rendere inospitale l’unico ambiente nel quale la vita umana è praticabile.
Se non ci sarà un’immediata presa di coscienza del fenomeno epocale che stiamo vivendo, le turbolenze, anche epidemiche, cui saremo sottoposti in futuro non si arresteranno, anzi tenderanno ad aumentare. Posizione questa espressa da uno slogan murale apparso in qualche metropoli del pianeta e poi diventato “virale” in rete: Non vogliamo un ritorno alla normalità perché la normalità era il problema. Il futuro non è un destino, l’epidemia evidenzia che i costrutti socioeconomici su cui si fonda la società globale contemporanea non sono ineluttabili. Nel volgere di poche settimane gli stili di vita individuali sono rapidamente mutati e lo stesso sistema economico si appresta a riconfigurare i propri assetti organizzativi e produttivi secondo modi impensabili solamente qualche mese fa. Insomma, lo slogan reso celebre da Margaret Thatcher – There is no alternative – sembra aver perso buona parte della sua forza vincolante. All’ineluttabilità si sostituisce la contingenza, e con essa l’apertura verso un’esigenza di maggiore giustizia sociale, a iniziare dai sistemi di sanità pubblica che, mostrando i limiti della retorica dell’eccellenza, si sono rivelati in alcuni casi incapaci di gestire l’emergenza. In questa direzione si muove, ad esempio, l’intervento di Michael Sandel, Are We All in This Together, che pone al centro della sua riflessione la necessità di ripensare “la globalizzazione guidata dal mercato” e di ridurre le ingiustificate asimmetrie tra lavoratori manuali e lavoratori intellettuali. Ciò che va riconsiderato è il divario di istruzione, reddito e cittadinanza tra chi in queste settimane ha continuato a lavorare per garantire i servizi essenziali (esponendosi al rischio del contagio) e chi invece ha potuto operare dal sicuro delle proprie abitazioni grazie agli strumenti offerti dalla telematica e da Internet. L’epidemia dovrebbe allora obbligarci a ripensare “al modo in cui affrontiamo la diseguaglianza” e a “fare i conti con i lati negativi e moralmente corrosivi della meritocrazia”.
A tappe forzate verso lo stato d’eccezione. Altri analisti evidenziano – spesso con toni apocalittici – un probabile esito distopico della pandemia: il mondo a venire sarà come quello di prima, solo in peggio. L’epidemia funziona come un potente acceleratore di tendenze già in atto, volte a incrementare i dispositivi di controllo e sorveglianza. L’egemonia incontrastata della biomedicina e il potere di decretare lo stato di eccezione disinnescano gli ostacoli rappresentati dai parlamenti e impoveriscono la socialità e la relazionalità umane. Pur di proteggere la nuda vita e di realizzare un ideale di immunità assoluta, perfino le necessità economiche e il lavoro possono essere sacrificati.
Questa è la prospettiva di analisi seguita da Giorgio Agamben in diversi interventi, tra cui l’iniziale Lo stato di eccezione provocato da un’emergenza immotivata. Arrivando a invertire il rapporto tra cause ed effetti, Agamben sostiene che l’epidemia, contro ogni evidenza epidemiologica e medica, sia da considerarsi letteralmente un’invenzione che i dispositivi del potere politico, memori della lezione hobbesiana, stanno attivando per sopprimere le libertà personali a vantaggio di un ideale di sicurezza totalizzante. Ciò che si prospetta – in nome della tutela del bios e degli interessi convergenti delle internet company e dei governi – è la tendenza verso lo “stato di eccezione come paradigma normale di governo”. Confinata in bolle trasparenti e catturata dalla rete del progetto biopolitico, la vita diviene l’oggetto di uno sguardo pervasivo e indiscreto, proprio mentre l’esercizio del potere, come una scatola nera, si fa più opaco e si sottrae al controllo democratico. Alla radicalità della posizione di Agamben ha fatto eco la risposta critica che Jean-Luc Nancy ha indirizzato al “vecchio amico”. Vale la pena riportarne un passaggio significativo: “Quasi trent’anni fa, i medici hanno giudicato che dovessi sottopormi a un trapianto di cuore. Giorgio fu una delle poche persone che mi consigliò di non ascoltarli. Se avessi seguito il suo consiglio probabilmente sarei morto ben presto”.
La perenne tracciabilità dei comportamenti individuali e il completo dispiegamento della società della sorveglianza e della trasparenza, unite all’incapacità tutta contemporanea di confrontarsi con la malattia e la morte, sono la preoccupazione anche di Byung-Chul Han. Pur non negando l’esistenza e la pericolosità del virus in quanto tale, le conclusioni a cui Han giunge convergono con la posizione di Agamben. Da un lato, anche per Han, ciò che l’epidemia rivela è la rinnovata ossessione per l’immunità, incrementata da un nemico che sfugge e si sottrae (tranne che nei laboratori) alla visibilità umana. Dall’altro, a subire una forte accelerazione è l’idea che “Sovrano” sia “chi dispone di dati”. In particolare in Oriente (il caso della Corea del Sud è in questo senso emblematico), dove la cultura della privacy sembra attenuata e prevale il collettivismo, la digitalizzazione “è una sorta di ebrezza collettiva” e i Big Data, non a caso, sono considerati “un enorme potenziale contro l’epidemia”.
Pensare l’epidemia. Tra queste due polarità si collocano molti degli interventi che con gli strumenti lessicali e concettuali della filosofia e delle scienze umane hanno cercato di interpretare un fenomeno, il cui senso antropologico, prima ancora che economico e politico, tende a sfuggire. Accanto all’impreparazione nella gestione sanitaria dell’epidemia, sembra quasi che le forme di vita occidentali siano incapaci di pensare una crisi che è anche culturale e simbolica. Se si escludono gli specialisti (virologi, immunologi ed epidemiologi), l’epidemia – proprio perché è strettamente connessa con il tema della morte – appartiene al campo dell’impensabile. Come ha ripetutamente ricordato l’antropologo Philippe Descola, anche in una recente intervista, la cosmologia naturalista che separa con un gesto ontologico radicale l’umano dagli esistenti non umani non contempla che un virus possa gettare nel caos intere strutture socioeconomiche, facendo sprofondare nell’angoscia interi popoli. Ilaria Capua, riferendosi al salto di specie effettuato dal virus e al focolaio cinese dell’epidemia, sottolinea come siamo stati noi a portare “la giungla dentro una megalopoli” e ora non sappiamo come gestire la prossimità forzata con il mondo animale da cui il virus proviene. L’hashtag “andrà tutto bene” e il mantra “è poco più di un’influenza” spesso ripetuto perfino dagli scienziati sono stati, allo stesso tempo, il sintomo del nostro disagio e i talismani linguistici con cui, almeno nella fase iniziale dell’epidemia, abbiamo cercato di confrontarci con l’inaspettato.
Sottovalutazione e presunzione. Bisogna pur riconoscerlo: non è andato tutto bene. E allora la domanda, su cui non si è riflettuto a dovere, è: perché non è andato tutto bene? L’ipotesi su cui è importante focalizzare l’attenzione riguarda la nostra presunzione, più precisamente la presunzione etnocentrica dell’Occidente. La nostra incapacità di gestire antropologicamente l’epidemia deriva anche dal fatto che un evento del genere non rientra nei frame cognitivi ed emotivi con cui diamo senso al nostro mondo. Certo, siamo a conoscenza delle epidemie, sappiamo che i virus sono agenti patogeni pericolosi e che ciascuno di noi potenzialmente e quotidianamente è esposto al contagio. Tuttavia, e questa è una credenza implicita, siamo stati a lungo convinti, nonostante le notizie e le immagini provenienti da Wuhan, che tutto ciò non sarebbe accaduto anche a noi. Dopo tutto, le epidemie si diffondono nei paesi sottosviluppati, o al massimo, in quelli in via di sviluppo, come la Cina appunto, dove la modernità più spinta convive e si sovrappone a stili di vita ancora in larga parte tradizionali. Anche in Occidente c’è preoccupazione per le epidemie africane di Dengue, Ebola, Zika e di altre malattie diffuse nel continente, ma è una preoccupazione mitigata dalla consapevolezza che si tratta di eventi epidemici che riguardano gli “altri”, e che al massimo interrogano la nostra coscienza morale, la nostra capacità di provare empatia per i rischi con cui i “dannati della terra” devono quotidianamente confrontarsi e la nostra volontà di attivare azioni di cooperazione. Da noi pericoli del genere non sarebbero potuti arrivare; e se anche fossero arrivati – così si è tacitamente pensato – l’igiene, le conoscenze biomediche e l’efficienza degli apparati sanitari sarebbero stati in grado di contenere e isolare il fenomeno. Dopotutto, la Sars agli inizi del duemila era rimasta confinata all’Estremo Oriente, limitandosi soltanto a minacciare l’Occidente ricco e sviluppato. Di quell’epidemia gli abitanti dei paesi ricchi sono stati soltanto spettatori: uno spettacolo tragico, duplicato anche in immagine nel film Contagion di Steven Soderbergh, che però si svolgeva altrove e che poteva essere vissuto con apprensione, ma mantenendo comunque la distanza di sicurezza.
Si potrebbe obiettare che nel novecento anche il nord del pianeta è stato investito da ondate epidemiche di origine virale: l’influenza Spagnola alla fine della prima guerra mondiale e poi, in tempi più recenti, l’Aids. Dalla Spagnola è però trascorso un secolo. Quella pandemia, che provocò secondo le stime più di cinquanta milioni di morti e la cui origine è ancora controversa, è comunque associata agli eventi bellici. Per questa ragione, di fatto, è rimasta in buona parte oscurata, come se si fosse trattato di un effetto collaterale del conflitto nel quale i morti in battaglia contavano certamente di più dei morti per malattia. L’Aids, invece, ha generato un panico collettivo soprattutto nella fase inziale dell’epidemia negli anni ottanta e novanta del novecento, prima che fosse introdotta un terapia farmacologica in grado di contenere gli effetti mortali dell’infezione. Oggi, l’Aids, grazie ai farmaci antivirali, è divenuta una malattia cronica. Tuttavia, non è questo il punto: l’Aids, diffusasi rapidamente in tutto il mondo, è una malattia a trasmissione sessuale che ha colpito nei paesi ricchi dell’Occidente soprattutto le minoranze già discriminate per le loro preferenze sessuali o la loro condizione, in particolare gay e prostitute. Questo fatto ha sicuramente avuto un impatto sul piano simbolico: larghissimi strati della popolazione, pur sentendosi minacciati, si ritenevano comunque indenni da un probabile contagio. Anche in questo caso, la minaccia riguardava gli “altri”: comportamenti accorti sul piano sessuale (e morale) avrebbero minimizzato il rischio.
Le turbolenze prossime venture. L’approccio iniziale al Covid-19 non è stato molto diverso, il rischio avrebbe solo lambito l’Occidente e sarebbe stato tenuto sotto controllo. Come si è potuto amaramente constatare le cose sono andate diversamente. Da una prospettiva filosofica, dunque, pensare l’epidemia significa anche adottare una postura antropologica più umile, significa rinunciare al nostro etnocentrismo e alla convinzione tipicamente antropocentrica che l’umano possa piegare alle sue esigenze o quantomeno rendere inoffensivo il vivente non umano, con la consapevolezza che i rischi non soltanto aumenteranno, ma ci riguarderanno. Perché le turbolenze non riguarderanno soltanto le periferie, ma tenderanno a manifestarsi anche nel centro del pianeta, investendo direttamente le nostre forme di vita, come confermano, ben oltre l’epidemia, anche le attuali tensioni razziali e sociali statunitensi.
Non dobbiamo soltanto chiederci quando l’epidemia sarà definitivamente sconfitta, magari grazie a un vaccino, per poter ripartire da dove ci eravamo fermati o per cercare, finalmente, di realizzare una maggiore giustizia sociale. Dobbiamo prima di tutto chiederci quando arriverà la prossima crisi e con quali modalità si manifesterà. L’epidemia non è soltanto il presente “sospeso”, fatto di isolamento, dolore, angoscia e morte. L’epidemia sembra annunciare le turbolenze sistemiche (ambientali, demografiche, epidemiologiche, politiche, economiche e sociali) di un futuro che per molti versi è già il nostro presente e che i modelli con cui dovremmo governare la complessità e i rischi globali si ostinano a non contemplare.
Note
“l’intervento di Michel Sandel…”: M.J. Sandel, Are We All in This Together, “New York Times”, 13 aprile 2020.
“Giorgio Agamben in diversi interventi…”: G. Agamben, Lo stato di eccezione provocato da un’emergenza immotivata, “il manifesto”, 26 febbraio 2020; con il titolo L’invenzione di un’epidemia, l’articolo è ora consultabile sul sito della casa editrice Quodlibet all’indirizzo https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia.
“Vale la pena riportarne un passaggio significativo…”: J.-L. Nancy, Eccezione virale, “Antinomie”, 27 febbraio 2020.
“sono la preoccupazione anche di Byung-Chul Han…”: B.-C. Han, La società del virus tra Stato di polizia e isteria della sopravvivenza, “Avvenire”, 7 aprile 2020.
“l’antropologo Philippe Descola…”: P. Descola, Nous sommes devenus des virus pour la planète, “Le Monde”, 20 maggio 2020. Per un approccio più ampio, cfr. Id., Oltre natura e cultura (2005), trad. it. di E. Bruni, a cura di N. Breda, SEID, Bologna 2014.
“Ilaria Capua…”: cfr. l’intervento di I. Capua a “Otto e mezzo”, LA7, 20 marzo 2020.
“uno spettacolo tragico, duplicato anche in immagine…”: cfr. Contagion, di S. Soderbergh. Usa, 2011.